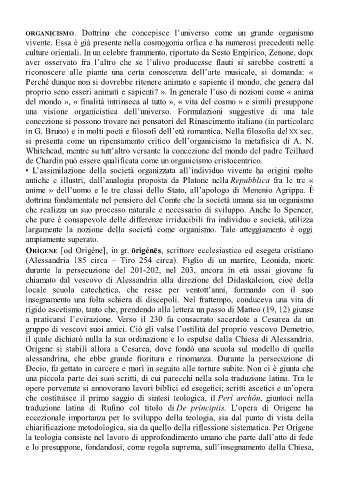Page 617 - Dizionario di Filosofia
P. 617
ORGANICISMO. Dottrina che concepisce l’universo come un grande organismo
vivente. Essa è già presente nella cosmogonia orfica e ha numerosi precedenti nelle
culture orientali. In un celebre frammento, riportato da Sesto Empirico, Zenone, dopo
aver osservato fra l’altro che se l’ulivo producesse flauti si sarebbe costretti a
riconoscere alle piante una certa conoscenza dell’arte musicale, si domanda: «
Perché dunque non si dovrebbe ritenere animato e sapiente il mondo, che genera dal
proprio seno esseri animati e sapienti? ». In generale l’uso di nozioni come « anima
del mondo », « finalità intrinseca al tutto », « vita del cosmo » e simili presuppone
una visione organicistica dell’universo. Formulazioni suggestive di una tale
concezione si possono trovare nei pensatori del Rinascimento italiano (in particolare
in G. Bruno) e in molti poeti e filosofi dell’età romantica. Nella filosofia del XX sec.
si presenta come un ripensamento critico dell’organicismo la metafisica di A. N.
Whitehead, mentre su tutt’altro versante la concezione del mondo del padre Teilhard
de Chardin può essere qualificata come un organicismo cristocentrico.
• L’assimilazione della società organizzata all’individuo vivente ha origini molto
antiche e illustri, dall’analogia proposta da Platone nella Repubblica fra le tre «
anime » dell’uomo e le tre classi dello Stato, all’apologo di Menenio Agrippa. È
dottrina fondamentale nel pensiero del Comte che la società umana sia un organismo
che realizza un suo processo naturale e necessario di sviluppo. Anche lo Spencer,
che pure è consapevole delle differenze irriducibili fra individuo e società, utilizza
largamente la nozione della società come organismo. Tale atteggiamento è oggi
ampiamente superato.
ORÌGENE [od Origène], in gr. ōrigénēs, scrittore ecclesiastico ed esegeta cristiano
(Alessandria 185 circa – Tiro 254 circa). Figlio di un martire, Leonida, morto
durante la persecuzione del 201-202, nel 203, ancora in età assai giovane fu
chiamato dal vescovo di Alessandria alla direzione del Didaskaleion, cioè della
locale scuola catechetica, che resse per ventott’anni, formando con il suo
insegnamento una folta schiera di discepoli. Nel frattempo, conduceva una vita di
rigido ascetismo, tanto che, prendendo alla lettera un passo di Matteo (19, 12) giunse
a praticarsi l’evirazione. Verso il 230 fu consacrato sacerdote a Cesarea da un
gruppo di vescovi suoi amici. Ciò gli valse l’ostilità del proprio vescovo Demetrio,
il quale dichiarò nulla la sua ordinazione e lo espulse dalla Chiesa di Alessandria.
Origene si stabilì allora a Cesarea, dove fondò una scuola sul modello di quella
alessandrina, che ebbe grande fioritura e rinomanza. Durante la persecuzione di
Decio, fu gettato in carcere e morì in seguito alle torture subite. Non ci è giunta che
una piccola parte dei suoi scritti, di cui parecchi nella sola traduzione latina. Tra le
opere pervenute si annoverano lavori biblici ed esegetici; scritti ascetici e un’opera
che costituisce il primo saggio di sintesi teologica, il Perì archôn, giuntoci nella
traduzione latina di Rufino col titolo di De principiis. L’opera di Origene ha
eccezionale importanza per lo sviluppo della teologia, sia dal punto di vista della
chiarificazione metodologica, sia da quello della riflessione sistematica. Per Origene
la teologia consiste nel lavoro di approfondimento umano che parte dall’atto di fede
e lo presuppone, fondandosi, come regola suprema, sull’insegnamento della Chiesa,