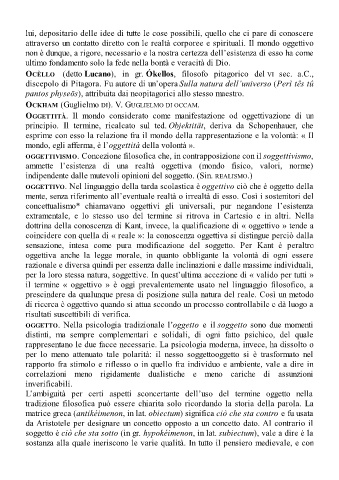Page 612 - Dizionario di Filosofia
P. 612
lui, depositario delle idee di tutte le cose possibili, quello che ci pare di conoscere
attraverso un contatto diretto con le realtà corporee e spirituali. Il mondo oggettivo
non è dunque, a rigore, necessario e la nostra certezza dell’esistenza di esso ha come
ultimo fondamento solo la fede nella bontà e veracità di Dio.
OCÈLLO (detto Lucano), in gr. Ókellos, filosofo pitagorico del VI sec. a.C.,
discepolo di Pitagora. Fu autore di un’opera Sulla natura dell’universo (Perì tês tû
pantos physeōs), attribuita dai neopitagorici allo stesso maestro.
OCKHAM (Guglielmo DI). V. GUGLIELMO DI OCCAM.
OGGETTITÀ. Il mondo considerato come manifestazione od oggettivazione di un
principio. Il termine, ricalcato sul ted. Objektität, deriva da Schopenhauer, che
esprime con esso la relazione fra il mondo della rappresentazione e la volontà: « Il
mondo, egli afferma, è l’oggettità della volontà ».
OGGETTIVISMO. Concezione filosofica che, in contrapposizione con il soggettivismo,
ammette l’esistenza di una realtà oggettiva (mondo fisico, valori, norme)
indipendente dalle mutevoli opinioni del soggetto. (Sin. REALISMO.)
OGGETTIVO. Nel linguaggio della tarda scolastica è oggettivo ciò che è oggetto della
mente, senza riferimento all’eventuale realtà o irrealtà di esso. Così i sostenitori del
concettualismo* chiamavano oggettivi gli universali, pur negandone l’esistenza
extramentale, e lo stesso uso del termine si ritrova in Cartesio e in altri. Nella
dottrina della conoscenza di Kant, invece, la qualificazione di « oggettivo » tende a
coincidere con quella di « reale »: la conoscenza oggettiva si distingue perciò dalla
sensazione, intesa come pura modificazione del soggetto. Per Kant è peraltro
oggettiva anche la legge morale, in quanto obbligante la volontà di ogni essere
razionale e diversa quindi per essenza dalle inclinazioni e dalle massime individuali,
per la loro stessa natura, soggettive. In quest’ultima accezione di « valido per tutti »
il termine « oggettivo » è oggi prevalentemente usato nel linguaggio filosofico, a
prescindere da qualunque presa di posizione sulla natura del reale. Così un metodo
di ricerca è oggettivo quando si attua secondo un processo controllabile e dà luogo a
risultati suscettibili di verifica.
OGGETTO. Nella psicologia tradizionale l’oggetto e il soggetto sono due momenti
distinti, ma sempre complementari e solidali, di ogni fatto psichico, del quale
rappresentano le due facce necessarie. La psicologia moderna, invece, ha dissolto o
per lo meno attenuato tale polarità: il nesso soggettooggetto si è trasformato nel
rapporto fra stimolo e riflesso o in quello fra individuo e ambiente, vale a dire in
correlazioni meno rigidamente dualistiche e meno cariche di assunzioni
inverificabili.
L’ambiguità per certi aspetti sconcertante dell’uso del termine oggetto nella
tradizione filosofica può essere chiarita solo ricordando la storia della parola. La
matrice greca (antikéimenon, in lat. obiectum) significa ciò che sta contro e fu usata
da Aristotele per designare un concetto opposto a un concetto dato. Al contrario il
soggetto è ciò che sta sotto (in gr. hypokéimenon, in lat. subiectum), vale a dire è la
sostanza alla quale ineriscono le varie qualità. In tutto il pensiero medievale, e con