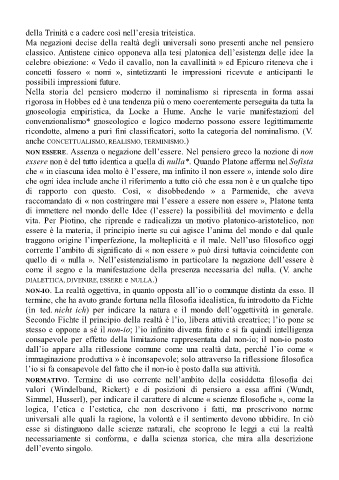Page 607 - Dizionario di Filosofia
P. 607
della Trinità e a cadere così nell’eresia triteistica.
Ma negazioni decise della realtà degli universali sono presenti anche nel pensiero
classico. Antistene cinico opponeva alla tesi platonica dell’esistenza delle idee la
celebre obiezione: « Vedo il cavallo, non la cavallinità » ed Epicuro riteneva che i
concetti fossero « nomi », sintetizzanti le impressioni ricevute e anticipanti le
possibili impressioni future.
Nella storia del pensiero moderno il nominalismo si ripresenta in forma assai
rigorosa in Hobbes ed è una tendenza più o meno coerentemente perseguita da tutta la
gnoseologia empiristica, da Locke a Hume. Anche le varie manifestazioni del
convenzionalismo* gnoseologico e logico moderno possono essere legittimamente
ricondotte, almeno a puri fini classificatori, sotto la categoria del nominalismo. (V.
anche CONCETTUALISMO, REALISMO, TERMINISMO.)
NON ESSERE. Assenza o negazione dell’essere. Nel pensiero greco la nozione di non
exsere non è del tutto identica a quella di nulla*. Quando Platone afferma nel Sofista
che « in ciascuna idea molto è l’essere, ma infinito il non essere », intende solo dire
che ogni idea include anche il riferimento a tutto ciò che essa non è e un qualche tipo
di rapporto con questo. Così, « disobbedendo » a Parmenide, che aveva
raccomandato di « non costringere mai l’essere a essere non essere », Platone tenta
di immettere nel mondo delle Idee (l’essere) la possibilità del movimento e della
vita. Per Piotino, che riprende e radicalizza un motivo platonico-aristotelico, non
essere è la materia, il principio inerte su cui agisce l’anima del mondo e dal quale
traggono origine l’imperfezione, la molteplicità e il male. Nell’uso filosofico oggi
corrente l’ambito di significato di « non essere » può dirsi tuttavia coincidente con
quello di « nulla ». Nell’esistenzialismo in particolare la negazione dell’essere è
come il segno e la manifestazione della presenza necessaria del nulla. (V. anche
DIALETTICA, DIVENIRE, ESSERE e NULLA.)
NON-IO. La realtà oggettiva, in quanto opposta all’io o comunque distinta da esso. Il
termine, che ha avuto grande fortuna nella filosofia idealistica, fu introdotto da Fichte
(in ted. nicht ich) per indicare la natura e il mondo dell’oggettività in generale.
Secondo Fichte il principio della realtà è l’io, libera attività creatrice; l’io pone se
stesso e oppone a sé il non-io; l’io infinito diventa finito e si fa quindi intelligenza
consapevole per effetto della limitazione rappresentata dal non-io; il non-io posto
dall’io appare alla riflessione comune come una realtà data, perché l’io come «
immaginazione produttiva » è inconsapevole; solo attraverso la riflessione filosofica
l’io si fa consapevole del fatto che il non-io è posto dalla sua attività.
NORMATIVO. Termine di uso corrente nell’ambito della cosiddetta filosofia dei
valori (Windelband, Rickert) e di posizioni di pensiero a essa affini (Wundt,
Simmel, Husserl), per indicare il carattere di alcune « scienze filosofiche », come la
logica, l’etica e l’estetica, che non descrivono i fatti, ma prescrivono norme
universali alle quali la ragione, la volontà e il sentimento devono ubbidire. In ciò
esse si distinguono dalle scienze naturali, che scoprono le leggi a cui la realtà
necessariamente si conforma, e dalla scienza storica, che mira alla descrizione
dell’evento singolo.