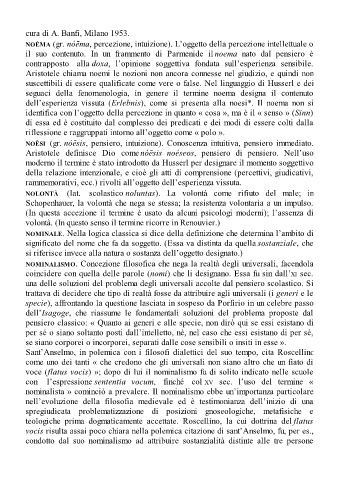Page 606 - Dizionario di Filosofia
P. 606
cura di A. Banfi, Milano 1953.
NOÈMA (gr. nóēma, percezione, intuizione). L’oggetto della percezione intellettuale o
il suo contenuto. In un frammento di Parmenide il noema nato dal pensiero è
contrapposto alla doxa, l’opinione soggettiva fondata sull’esperienza sensibile.
Aristotele chiama noemi le nozioni non ancora connesse nel giudizio, e quindi non
suscettibili di essere qualificate come vere o false. Nel linguaggio di Husserl e dei
seguaci della fenomenologia, in genere il termine noema designa il contenuto
dell’esperienza vissuta (Erlebnis), come si presenta alla noesi*. Il noema non si
identifica con l’oggetto della percezione in quanto « cosa », ma è il « senso » (Sinn)
di essa ed è costituito dal complesso dei predicati e dei modi di essere colti dalla
riflessione e raggruppati intorno all’oggetto come « polo ».
NOÈSI (gr. nóēsis, pensiero, intuizione). Conoscenza intuitiva, pensiero immediato.
Aristotele definisce Dio come nóēsis noéseos, pensiero di pensiero. Nell’uso
moderno il termine è stato introdotto da Husserl per designare il momento soggettivo
della relazione intenzionale, e cioè gli atti di comprensione (percettivi, giudicativi,
rammemorativi, ecc.) rivolti all’oggetto dell’esperienza vissuta.
NOLONTÀ (lat. scolastico noluntas). La volontà come rifiuto del male; in
Schopenhauer, la volontà che nega se stessa; la resistenza volontaria a un impulso.
(In questa accezione il termine è usato da alcuni psicologi moderni); l’assenza di
volontà. (In questo senso il termine ricorre in Renouvier.)
NOMINALE. Nella logica classica si dice della definizione che determina l’ambito di
significato del nome che fa da soggetto. (Essa va distinta da quella sostanziale, che
si riferisce invece alla natura o sostanza dell’oggetto designato.)
NOMINALISMO. Concezione filosofica che nega la realtà degli universali, facendola
coincidere con quella delle parole (nomi) che li designano. Essa fu sin dall’XI sec.
una delle soluzioni del problema degli universali accolte dal pensiero scolastico. Si
trattava di decidere che tipo di realtà fosse da attribuire agli universali (i generi e le
specie), affrontando la questione lasciata in sospeso da Porfirio in un celebre passo
dell’Isagoge, che riassume le fondamentali soluzioni del problema proposte dal
pensiero classico: « Quanto ai generi e alle specie, non dirò qui se essi esistano di
per sé o siano soltanto posti dall’intelletto, né, nel caso che essi esistano di per sé,
se siano corporei o incorporei, separati dalle cose sensibili o insiti in esse ».
Sant’Anselmo, in polemica con i filosofi dialettici del suo tempo, cita Roscellino
come uno dei tanti « che credono che gli universali non siano altro che un fiato di
voce (flatus vocis) »; dopo di lui il nominalismo fu di solito indicato nelle scuole
con l’espressione sententia vocum, finché col XV sec. l’uso del termine «
nominalista » cominciò a prevalere. Il nominalismo ebbe un’importanza particolare
nell’evoluzione della filosofia medievale ed è testimonianza dell’inizio di una
spregiudicata problematizzazione di posizioni gnoseologiche, metafisiche e
teologiche prima dogmaticamente accettate. Roscellino, la cui dottrina del flatus
vocis risulta assai poco chiara nella polemica citazione di sant’Anselmo, fu, per es.,
condotto dal suo nominalismo ad attribuire sostanzialità distinte alle tre persone