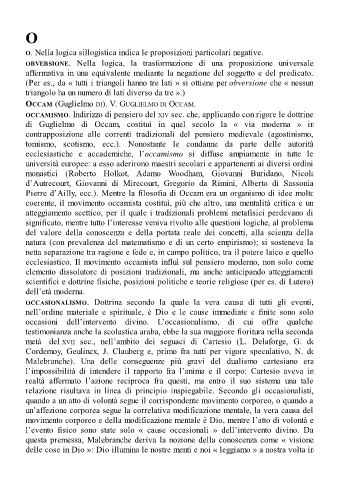Page 611 - Dizionario di Filosofia
P. 611
O
O. Nella logica sillogistica indica le proposizioni particolari negative.
OBVEBSIONE. Nella logica, la trasformazione di una proposizione universale
affermativa in una equivalente mediante la negazione del soggetto e del predicato.
(Per es., da « tutti i triangoli hanno tre lati » si ottiene per obversione che « nessun
triangolo ha un numero di lati diverso da tre ».)
OCCAM (Guglielmo DI). V. GUGLIELMO DI OCCAM.
OCCAMISMO. Indirizzo di pensiero del XIV sec. che, applicando con rigore le dottrine
di Guglielmo di Occam, costituì in quel secolo la « via moderna » in
contrapposizione alle correnti tradizionali del pensiero medievale (agostinismo,
tomismo, scotismo, ecc.). Nonostante le condanne da parte delle autorità
ecclesiastiche e accademiche, l’occamismo si diffuse ampiamente in tutte le
università europee: a esso aderirono maestri secolari e appartenenti ai diversi ordini
monastici (Roberto Holkot, Adamo Woodham, Giovanni Buridano, Nicola
d’Autrecourt, Giovanni di Mirecourt, Gregorio da Rimini, Alberto di Sassonia,
Pierre d’Ailly, ecc.). Mentre la filosofia di Occam era un organismo di idee molto
coerente, il movimento occamista costituì, più che altro, una mentalità critica e un
atteggiamento scettico, per il quale i tradizionali problemi metafisici perdevano di
significato, mentre tutto l’interesse veniva rivolto alle questioni logiche, al problema
del valore della conoscenza e della portata reale dei concetti, alla scienza della
natura (con prevalenza del matematismo e di un certo empirismo); si sosteneva la
netta separazione tra ragione e fede e, in campo politico, tra il potere laico e quello
ecclesiastico. Il movimento occamista influì sul pensiero moderno, non solo come
elemento dissolutore di posizioni tradizionali, ma anche anticipando atteggiamenti
scientifici e dottrine fisiche, posizioni politiche e teorie religiose (per es. di Lutero)
dell’età moderna.
OCCASIONALISMO. Dottrina secondo la quale la vera causa di tutti gli eventi,
nell’ordine materiale e spirituale, è Dio e le cause immediate e finite sono solo
occasioni dell’intervento divino. L’occasionalismo, di cui offre qualche
testimonianza anche la scolastica araba, ebbe la sua maggiore fioritura nella seconda
metà del XVII sec., nell’ambito dei seguaci di Cartesio (L. Delaforge, G. de
Cordemoy, Geulincx, J. Clauberg e, primo fra tutti per vigore speculativo, N. de
Malebranche). Una delle conseguenze più gravi del dualismo cartesiano era
l’impossibilità di intendere il rapporto fra l’anima e il corpo: Cartesio aveva in
realtà affermato l’azione reciproca fra questi, ma entro il suo sistema una tale
relazione risultava in linea di principio inspiegabile. Secondo gli occasionalisti,
quando a un atto di volontà segue il corrispondente movimento corporeo, o quando a
un’affezione corporea segue la correlativa modificazione mentale, la vera causa del
movimento corporeo e della modificazione mentale è Dio, mentre l’atto di volontà e
l’evento fisico sono state solo « cause occasionali » dell’intervento divino. Da
questa premessa, Malebranche deriva la nozione della conoscenza come « visione
delle cose in Dio »: Dio illumina le nostre menti e noi « leggiamo » a nostra volta in