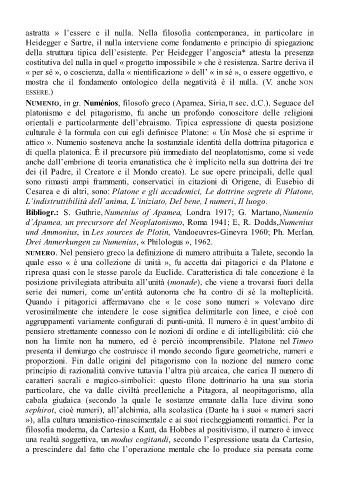Page 609 - Dizionario di Filosofia
P. 609
astratta » l’essere e il nulla. Nella filosofia contemporanea, in particolare in
Heidegger e Sartre, il nulla interviene come fondamento e principio di spiegazione
della struttura tipica dell’esistente. Per Heidegger l’angoscia* attesta la presenza
costitutiva del nulla in quel « progetto impossibile » che è resistenza. Sartre deriva il
« per sé », o coscienza, dalla « nientificazione » dell’ « in sé », o essere oggettivo, e
mostra che il fondamento ontologico della negatività è il nulla. (V. anche NON
ESSERE.)
NUMENIO, in gr. Numénios, filosofo greco (Apamea, Siria, II sec. d.C.). Seguace del
platonismo e del pitagorismo, fu anche un profondo conoscitore delle religioni
orientali e particolarmente dell’ebraismo. Tipica espressione di questa posizione
culturale è la formula con cui egli definisce Platone: « Un Mosè che si esprime in
attico ». Numenio sosteneva anche la sostanziale identità della dottrina pitagorica e
di quella platonica. È il precursore più immediato del neoplatonismo, come si vede
anche dall’embrione di teoria emanatistica che è implicito nella sua dottrina dei tre
dei (il Padre, il Creatore e il Mondo creato). Le sue opere principali, delle quali
sono rimasti ampi frammenti, conservatici in citazioni di Origene, di Eusebio di
Cesarea e di altri, sono: Platone e gli accademici, Le dottrine segrete di Platone,
L’indistruttibilità dell’anima, L’iniziato, Del bene, I numeri, Il luogo.
Bibliogr.: S. Guthrie, Numenius of Apamea, Londra 1917; G. Martano, Numenio
d’Apamea, un precursore del Neoplatonismo, Roma 1941; E, R. Dodds, Numenius
und Ammonius, in Les sources de Plotin, Vandoeuvres-Ginevra 1960; Ph. Merlan,
Drei Anmerkungen zu Numenius, « Philologus », 1962.
NUMERO. Nel pensiero greco la definizione di numero attribuita a Talete, secondo la
quale esso « è una collezione di unità », fu accetta dai pitagorici e da Platone e
ripresa quasi con le stesse parole da Euclide. Caratteristica di tale concezione è la
posizione privilegiata attribuita all’unità (monade), che viene a trovarsi fuori della
serie dei numeri, come un’entità autonoma che ha contro di sé la molteplicità.
Quando i pitagorici affermavano che « le cose sono numeri » volevano dire
verosimilmente che intendere le cose significa delimitarle con linee, e cioè con
aggruppamenti variamente configurati di punti-unità. Il numero è in quest’ambito di
pensiero strettamente connesso con le nozioni di ordine e di intelligibilità: ciò che
non ha limite non ha numero, ed è perciò incomprensibile. Platone nel Timeo
presenta il demiurgo che costruisce il mondo secondo figure geometriche, numeri e
proporzioni. Fin dalle origini del pitagorismo con la nozione del numero come
principio di razionalità convive tuttavia l’altra più arcaica, che carica Il numero di
caratteri sacrali e magico-simbolici: questo filone dottrinario ha una sua storia
particolare, che va dalle civiltà preelleniche a Pitagora, al neopitagorismo, alla
cabala giudaica (secondo la quale le sostanze emanate dalla luce divina sono
sephirot, cioè numeri), all’alchimia, alla scolastica (Dante ha i suoi « numeri sacri
»), alla cultura umanistico-rinascimentale e ai suoi riecheggiamenti romantici. Per la
filosofia moderna, da Cartesio a Kant, da Hobbes al positivismo, il numero è invece
una realtà soggettiva, un modus cogitandi, secondo l’espressione usata da Cartesio,
a prescindere dal fatto che l’operazione mentale che lo produce sia pensata come