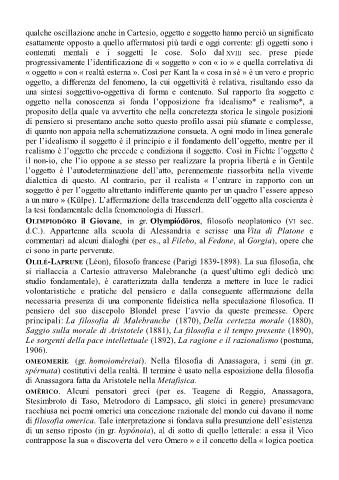Page 613 - Dizionario di Filosofia
P. 613
qualche oscillazione anche in Cartesio, oggetto e soggetto hanno perciò un significato
esattamente opposto a quello affermatosi più tardi e oggi corrente: gli oggetti sono i
contenuti mentali e i soggetti le cose. Solo dal XVIII sec. prese piede
progressivamente l’identificazione di « soggetto » con « io » e quella correlativa di
« oggetto » con « realtà esterna ». Così per Kant la « cosa in sé » è un vero e proprio
oggetto, a differenza del fenomeno, la cui oggettività è relativa, risultando esso da
una sintesi soggettivo-oggettiva di forma e contenuto. Sul rapporto fra soggetto e
oggetto nella conoscenza si fonda l’opposizione fra idealismo* e realismo*, a
proposito della quale va avvertito che nella concretezza storica le singole posizioni
di pensiero si presentano anche sotto questo profilo assai più sfumate e complesse,
di quanto non appaia nella schematizzazione consueta. A ogni modo in linea generale
per l’idealismo il soggetto è il principio e il fondamento dell’oggetto, mentre per il
realismo è l’oggetto che precede e condiziona il soggetto. Così in Fichte l’oggetto è
il non-io, che l’io oppone a se stesso per realizzare la propria libertà e in Gentile
l’oggetto è l’autodeterminazione dell’atto, perennemente riassorbita nella vivente
dialettica di questo. Al contrario, per il realista « l’entrare in rapporto con un
soggetto è per l’oggetto altrettanto indifferente quanto per un quadro l’essere appeso
a un muro » (Külpe). L’affermazione della trascendenza dell’oggetto alla coscienza è
la tesi fondamentale della fenomenologia di Husserl.
OLIMPIODÒRO il Giovane, in gr. Olympiódōros, filosofo neoplatonico (VI sec.
d.C.). Appartenne alla scuola di Alessandria e scrisse una Vita di Platone e
commentari ad alcuni dialoghi (per es., al Filebo, al Fedone, al Gorgia), opere che
ci sono in parte pervenute.
OLILÉ-LAPRUNE (Léon), filosofo francese (Parigi 1839-1898). La sua filosofia, che
si riallaccia a Cartesio attraverso Malebranche (a quest’ultimo egli dedicò uno
studio fondamentale), è caratterizzata dalla tendenza a mettere in luce le radici
volontaristiche e pratiche del pensiero e dalla conseguente affermazione della
necessaria presenza di una componente fideistica nella speculazione filosofica. Il
pensiero del suo discepolo Blondel prese l’avvio da queste premesse. Opere
principali: La filosofia di Malebranche (1870), Della certezza morale (1880),
Saggio sulla morale di Aristotele (1881), La filosofia e il tempo presente (1890),
Le sorgenti della pace intellettuale (1892), La ragione e il razionalismo (postuma,
1906).
OMEOMERÌE (gr. homoioméreiai). Nella filosofia di Anassagora, i semi (in gr.
spérmata) costitutivi della realtà. Il termine è usato nella esposizione della filosofia
di Anassagora fatta da Aristotele nella Metafisica.
OMÈRICO. Alcuni pensatori greci (per es. Teagene di Reggio, Anassagora,
Stesimbroto di Taso, Metrodoro di Lampsaco, gli stoici in genere) presumevano
racchiusa nei poemi omerici una concezione razionale del mondo cui davano il nome
di filosofia omerica. Tale interpretazione si fondava sulla presunzione dell’esistenza
di un senso riposto (in gr. hypónoia), al di sotto di quello letterale: a essa il Vico
contrappose la sua « discoverta del vero Omero » e il concetto della « logica poetica