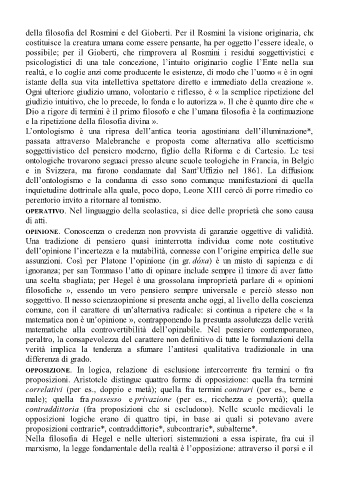Page 615 - Dizionario di Filosofia
P. 615
della filosofia del Rosmini e del Gioberti. Per il Rosmini la visione originaria, che
costituisce la creatura umana come essere pensante, ha per oggetto l’essere ideale, o
possibile; per il Gioberti, che rimprovera al Rosmini i residui soggettivistici e
psicologistici di una tale concezione, l’intuito originario coglie l’Ente nella sua
realtà, e lo coglie anzi come producente le esistenze, di modo che l’uomo « è in ogni
istante della sua vita intellettiva spettatore diretto e immediato della creazione ».
Ogni ulteriore giudizio umano, volontario e riflesso, è « la semplice ripetizione del
giudizio intuitivo, che lo precede, lo fonda e lo autorizza ». Il che è quanto dire che «
Dio a rigore di termini è il primo filosofo e che l’umana filosofia è la continuazione
e la ripetizione della filosofia divina ».
L’ontologismo è una ripresa dell’antica teoria agostiniana dell’illuminazione*,
passata attraverso Malebranche e proposta come alternativa allo scetticismo
soggettivistico del pensiero moderno, figlio della Riforma e di Cartesio. Le tesi
ontologiche trovarono seguaci presso alcune scuole teologiche in Francia, in Belgio
e in Svizzera, ma furono condannate dal Sant’Uffizio nel 1861. La diffusione
dell’ontologismo e la condanna di esso sono comunque manifestazioni di quella
inquietudine dottrinale alla quale, poco dopo, Leone XIII cercò di porre rimedio col
perentorio invito a ritornare al tomismo.
OPERATIVO. Nel linguaggio della scolastica, si dice delle proprietà che sono causa
di atti.
OPINIONE. Conoscenza o credenza non provvista di garanzie oggettive di validità.
Una tradizione di pensiero quasi ininterrotta individua come note costitutive
dell’opinione l’incertezza e la mutabilità, connesse con l’origine empirica delle sue
assunzioni. Così per Platone l’opinione (in gr. dóxa) è un misto di sapienza e di
ignoranza; per san Tommaso l’atto di opinare include sempre il timore di aver fatto
una scelta sbagliata; per Hegel è una grossolana improprietà parlare di « opinioni
filosofiche », essendo un vero pensiero sempre universale e perciò stesso non
soggettivo. Il nesso scienzaopinione si presenta anche oggi, al livello della coscienza
comune, con il carattere di un’alternativa radicale: si continua a ripetere che « la
matematica non è un’opinione », contrapponendo la presunta assolutezza delle verità
matematiche alla controvertibilità dell’opinabile. Nel pensiero contemporaneo,
peraltro, la consapevolezza del carattere non definitivo di tutte le formulazioni della
verità implica la tendenza a sfumare l’antitesi qualitativa tradizionale in una
differenza di grado.
OPPOSIZIONE. In logica, relazione di esclusione intercorrente fra termini o fra
proposizioni. Aristotele distingue quattro forme di opposizione: quella fra termini
correlativi (per es., doppio e metà); quella fra termini contrari (per es., bene e
male); quella fra possesso e privazione (per es., ricchezza e povertà); quella
contraddittoria (fra proposizioni che si escludono). Nelle scuole medievali le
opposizioni logiche erano di quattro tipi, in base ai quali si potevano avere
proposizioni contrarie*, contraddittorie*, subcontrarie*, subalterne*.
Nella filosofia di Hegel e nelle ulteriori sistemazioni a essa ispirate, fra cui il
marxismo, la legge fondamentale della realtà è l’opposizione: attraverso il porsi e il