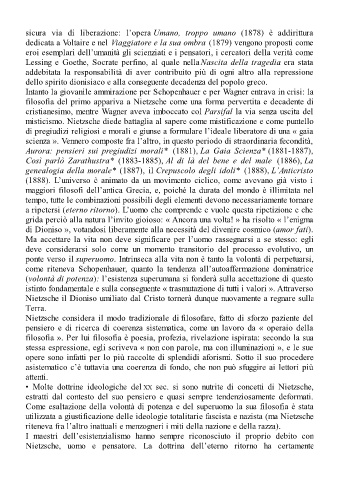Page 603 - Dizionario di Filosofia
P. 603
sicura via di liberazione: l’opera Umano, troppo umano (1878) è addirittura
dedicata a Voltaire e nel Viaggiatore e la sua ombra (1879) vengono proposti come
eroi esemplari dell’umanità gli scienziati e i pensatori, i cercatori della verità come
Lessing e Goethe, Socrate perfino, al quale nella Nascita della tragedia era stata
addebitata la responsabilità di aver contribuito più di ogni altro alla repressione
dello spirito dionisiaco e alla conseguente decadenza del popolo greco.
Intanto la giovanile ammirazione per Schopenhauer e per Wagner entrava in crisi: la
filosofia del primo appariva a Nietzsche come una forma pervertita e decadente di
cristianesimo, mentre Wagner aveva imboccato col Parsifal la via senza uscita del
misticismo. Nietzsche diede battaglia al sapere come mistificazione e come puntello
di pregiudizi religiosi e morali e giunse a formulare l’ideale liberatore di una « gaia
scienza ». Vennero composte fra l’altro, in questo periodo di straordinaria fecondità,
Aurora: pensieri sui pregiudizi morali* (1881), La Gaia Scienza* (1881-1887),
Così parlò Zarathustra* (1883-1885), Al di là del bene e del male (1886), La
genealogia della morale* (1887), il Crepuscolo degli idoli* (1888), L’Anticristo
(1888). L’universo è animato da un movimento ciclico, come avevano già visto i
maggiori filosofi dell’antica Grecia, e, poiché la durata del mondo è illimitata nel
tempo, tutte le combinazioni possibili degli elementi devono necessariamente tornare
a ripetersi (eterno ritorno). L’uomo che comprende e vuole questa ripetizione e che
grida perciò alla natura l’invito gioioso: « Ancora una volta! » ha risolto « l’enigma
di Dioniso », votandosi liberamente alla necessità del divenire cosmico (amor fati).
Ma accettare la vita non deve significare per l’uomo rassegnarsi a se stesso: egli
deve considerarsi solo come un momento transitorio del processo evolutivo, un
ponte verso il superuomo. Intrinseca alla vita non è tanto la volontà di perpetuarsi,
come riteneva Schopenhauer, quanto la tendenza all’autoaffermazione dominatrice
(volontà di potenza): l’esistenza superumana si fonderà sulla accettazione di questo
istinto fondamentale e sulla conseguente « trasmutazione di tutti i valori ». Attraverso
Nietzsche il Dioniso umiliato dal Cristo tornerà dunque nuovamente a regnare sulla
Terra.
Nietzsche considera il modo tradizionale di filosofare, fatto di sforzo paziente del
pensiero e di ricerca di coerenza sistematica, come un lavoro da « operaio della
filosofia ». Per lui filosofia è poesia, profezia, rivelazione ispirata: secondo la sua
stessa espressione, egli scriveva « non con parole, ma con illuminazioni », e le sue
opere sono infatti per lo più raccolte di splendidi aforismi. Sotto il suo procedere
asistematico c’è tuttavia una coerenza di fondo, che non può sfuggire ai lettori più
attenti.
• Molte dottrine ideologiche del XX sec. si sono nutrite di concetti di Nietzsche,
estratti dal contesto del suo pensiero e quasi sempre tendenziosamente deformati.
Come esaltazione della volontà di potenza e del superuomo la sua filosofia è stata
utilizzata a giustificazione delle ideologie totalitarie fascista e nazista (ma Nietzsche
riteneva fra l’altro inattuali e menzogneri i miti della nazione e della razza).
I maestri dell’esistenzialismo hanno sempre riconosciuto il proprio debito con
Nietzsche, uomo e pensatore. La dottrina dell’eterno ritorno ha certamente