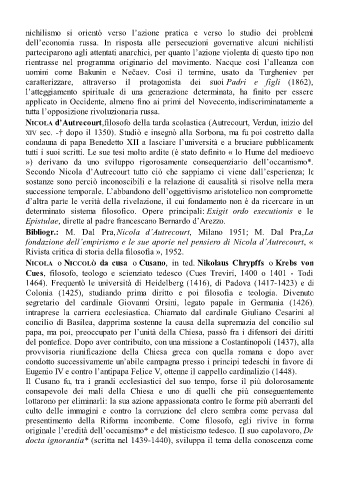Page 600 - Dizionario di Filosofia
P. 600
nichilismo si orientò verso l’azione pratica e verso lo studio dei problemi
dell’economia russa. In risposta alle persecuzioni governative alcuni nichilisti
parteciparono agli attentati anarchici, per quanto l’azione violenta di questo tipo non
rientrasse nel programma originario del movimento. Nacque così l’alleanza con
uomini come Bakunin e Nečaev. Così il termine, usato da Turgheniev per
caratterizzare, attraverso il protagonista dei suoi Padri e figli (1862),
l’atteggiamento spirituale di una generazione determinata, ha finito per essere
applicato in Occidente, almeno fino ai primi del Novecento, indiscriminatamente a
tutta l’opposizione rivoluzionaria russa.
NICOLA d’Autrecourt,filosofo della tarda scolastica (Autrecourt, Verdun, inizio del
XIV sec. -† dopo il 1350). Studiò e insegnò alla Sorbona, ma fu poi costretto dalla
condauna di papa Benedetto XII a lasciare l’università e a bruciare pubblicamente
tutti i suoi scritti. Le sue tesi molto ardite (è stato definito « lo Hume del medioevo
») derivano da uno sviluppo rigorosamente consequenziario dell’occamismo*.
Secondo Nicola d’Autrecourt tutto ciò che sappiamo ci viene dall’esperienza; le
sostanze sono perciò inconoscibili e la relazione di causalità si risolve nella mera
successione temporale. L’abbandono dell’oggettivismo aristotelico non compromette
d’altra parte le verità della rivelazione, il cui fondamento non è da ricercare in un
determinato sistema filosofico. Opere principali: Exigit ordo executionis e le
Epistulae, dirette al padre francescano Bernardo d’Arezzo.
Bibliogr.: M. Dal Pra, Nicola d’Autrecourt, Milano 1951; M. Dal Pra, La
fondazione dell’empirismo e le sue aporie nel pensiero di Nicola d’Autrecourt, «
Rivista critica di storia della filosofia », 1952.
NICOLA o NICCOLÒ da cusa o Cusano, in ted. Nikolaus Chrypffs o Krebs von
Cues, filosofo, teologo e scienziato tedesco (Cues Treviri, 1400 o 1401 - Todi
1464). Frequentò le università di Heidelberg (1416), di Padova (1417-1423) e di
Colonia (1425), studiando prima diritto e poi filosofia e teologia. Divenuto
segretario del cardinale Giovanni Orsini, legato papale in Germania (1426),
intraprese la carriera ecclesiastica. Chiamato dal cardinale Giuliano Cesarini al
concilio di Basilea, dapprima sostenne la causa della supremazia del concilio sul
papa, ma poi, preoccupato per l’unità della Chiesa, passò fra i difensori dei diritti
del pontefice. Dopo aver contribuito, con una missione a Costantinopoli (1437), alla
provvisoria riunificazione della Chiesa greca con quella romana e dopo aver
condotto successivamente un’abile campagna presso i principi tedeschi in favore di
Eugenio IV e contro l’antipapa Felice V, ottenne il cappello cardinalizio (1448).
Il Cusano fu, tra i grandi ecclesiastici del suo tempo, forse il più dolorosamente
consapevole dei mali della Chiesa e uno di quelli che più conseguentemente
lottarono per eliminarli: la sua azione appassionata contro le forme più aberranti del
culto delle immagini e contro la corruzione del clero sembra come pervasa dal
presentimento della Riforma incombente. Come filosofo, egli rivive in forma
originale l’eredità dell’occamismo* e del misticismo tedesco. Il suo capolavoro, De
docta ignorantia* (scritta nel 1439-1440), sviluppa il tema della conoscenza come