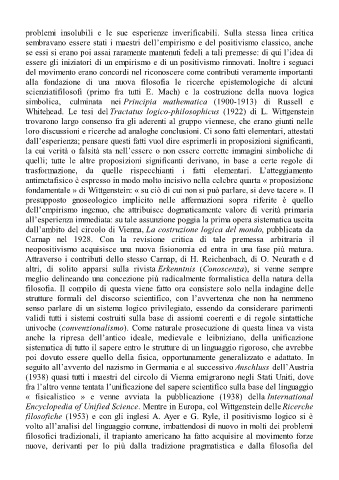Page 595 - Dizionario di Filosofia
P. 595
problemi insolubili e le sue esperienze inverificabili. Sulla stessa linea critica
sembravano essere stati i maestri dell’empirismo e del positivismo classico, anche
se essi si erano poi assai raramente mantenuti fedeli a tali premesse: di qui l’idea di
essere gli iniziatori di un empirismo e di un positivismo rinnovati. Inoltre i seguaci
del movimento erano concordi nel riconoscere come contributi veramente importanti
alla fondazione di una nuova filosofia le ricerche epistemologiche di alcuni
scienziatifilosofi (primo fra tutti E. Mach) e la costruzione della nuova logica
simbolica, culminata nei Principia mathematica (1900-1913) di Russell e
Whitehead. Le tesi del Tractatus logico-philosophicus (1922) di L. Wittgenstein
trovarono largo consenso fra gli aderenti al gruppo viennese, che erano giunti nelle
loro discussioni e ricerche ad analoghe conclusioni. Ci sono fatti elementari, attestati
dall’esperienza; pensare questi fatti vuol dire esprimerli in proposizioni significanti,
la cui verità o falsità sta nell’essere o non essere corrette immagini simboliche di
quelli; tutte le altre proposizioni significanti derivano, in base a certe regole di
trasformazione, da quelle rispecchianti i fatti elementari. L’atteggiamento
antimetafisico è espresso in modo molto incisivo nella celebre quarta « proposizione
fondamentale » di Wittgenstein: « su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere ». Il
presupposto gnoseologico implicito nelle affermazioni sopra riferite è quello
dell’empirismo ingenuo, che attribuisce dogmaticamente valore di verità primaria
all’esperienza immediata: su tale assunzione poggia la prima opera sistematica uscita
dall’ambito del circolo di Vienna, La costruzione logica del mondo, pubblicata da
Carnap nel 1928. Con la revisione critica di tale premessa arbitraria il
neopositivismo acquisisce una nuova fisionomia ed entra in una fase più matura.
Attraverso i contributi dello stesso Carnap, di H. Reichenbach, di O. Neurath e di
altri, di solito apparsi sulla rivista Erkenntnis (Conoscenza), si venne sempre
meglio delineando una concezione più radicalmente formalistica della natura della
filosofia. Il compilo di questa viene fatto ora consistere solo nella indagine delle
strutture formali del discorso scientifico, con l’avvertenza che non ha nemmeno
senso parlare di un sistema logico privilegiato, essendo da considerare parimenti
validi tutti i sistemi costruiti sulla base di assiomi coerenti e di regole sintattiche
univoche (convenzionalismo). Come naturale prosecuzione di questa linea va vista
anche la ripresa dell’antico ideale, medievale e leibniziano, della unificazione
sistematica di tutto il sapere entro le strutture di un linguaggio rigoroso, che avrebbe
poi dovuto essere quello della fisica, opportunamente generalizzato e adattato. In
seguito all’avvento del nazismo in Germania e al successivo Anschluss dell’Austria
(1938) quasi tutti i maestri del circolo di Vienna emigrarono negli Stati Uniti, dove
fra l’altro venne tentata l’unificazione del sapere scientifico sulla base del linguaggio
« fisicalistico » e venne avviata la pubblicazione (1938) della International
Encyclopedia of Unified Science. Mentre in Europa, col Wittgenstein delle Ricerche
filosofiche (1953) e con gli inglesi A. Ayer e G. Ryle, il positivismo logico si è
volto all’analisi del linguaggio comune, imbattendosi di nuovo in molti dei problemi
filosofici tradizionali, il trapianto americano ha fatto acquisire al movimento forze
nuove, derivanti per lo più dalla tradizione pragmatistica e dalla filosofia del