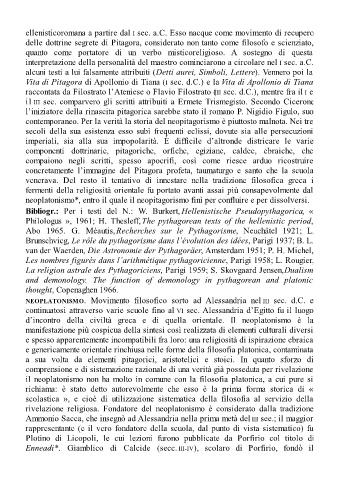Page 593 - Dizionario di Filosofia
P. 593
ellenisticoromana a partire dal I sec. a.C. Esso nacque come movimento di recupero
delle dottrine segrete di Pitagora, considerato non tanto come filosofo e scienziato,
quanto come portatore di un verbo misticoreligioso. A sostegno di questa
interpretazione della personalità del maestro cominciarono a circolare nel I sec. a.C.
alcuni testi a lui falsamente attribuiti (Detti aurei, Simboli, Lettere). Vennero poi la
Vita di Pitagora di Apollonio di Tiana (I sec. d.C.) e la Vita di Apollonio di Tiana
raccontata da Filostrato l’Ateniese o Flavio Filostrato (III sec. d.C.), mentre fra il I e
il III sec. comparvero gli scritti attribuiti a Ermete Trismegisto. Secondo Cicerone
l’iniziatore della rinascita pitagorica sarebbe stato il romano P. Nigidio Figulo, suo
contemporaneo. Per la verità la storia del neopitagorismo è piuttosto malnota. Nei tre
secoli della sua esistenza esso subì frequenti eclissi, dovute sia alle persecuzioni
imperiali, sia alla sua impopolarità. È diffìcile d’altronde districare le varie
componenti dottrinarie, pitagoriche, orfiche, egiziane, caldee, ebraiche, che
compaiono negli scritti, spesso apocrifi, così come riesce arduo ricostruire
concretamente l’immagine del Pitagora profeta, taumaturgo e santo che la scuola
venerava. Del resto il tentativo di innestare nella tradizione filosofica greca i
fermenti della religiosità orientale fu portato avanti assai più consapevolmente dal
neoplatonismo*, entro il quale il neopitagorismo finì per confluire e per dissolversi.
Bibliogr.: Per i testi del N.: W. Burkert, Hellenistische Pseudopythagorica, «
Philologus », 1961; H. Thesleff, The pythagorean texts of the hellenistic period,
Abo 1965. G. Méautis, Recherches sur le Pythagorisme, Neuchâtel 1921; L.
Brunschvicg, Le rôle du pythagorisme dans l’évolution des idées, Parigi 1937; B. L.
van der Waerden, Die Astronomie der Pythagoräer, Amsterdam 1951; P. H. Michel,
Les nombres figurés dans l’arithmétique pythagoricienne, Parigi 1958; L. Rougier,
La religion astrale des Pythagoriciens, Parigi 1959; S. Skovgaard Jensen, Dualism
and demonology. The function of demonology in pythagorean and platonic
thought, Copenaghen 1966.
NEOPLATONISMO. Movimento filosofico sorto ad Alessandria nel III sec. d.C. e
continuatosi attraverso varie scuole fino al VI sec. Alessandria d’Egitto fu il luogo
d’incontro della civiltà greca e di quella orientale. Il neoplatonismo è la
manifestazione più cospicua della sintesi così realizzata di elementi culturali diversi
e spesso apparentemente incompatibili fra loro: una religiosità di ispirazione ebraica
e genericamente orientale rinchiusa nelle forme della filosofia platonica, contaminata
a sua volta da elementi pitagorici, aristotelici e stoici. In quanto sforzo di
comprensione e di sistemazione razionale di una verità già posseduta per rivelazione
il neoplatonismo non ha molto in comune con la filosofia platonica, a cui pure si
richiama: è stato detto autorevolmente che esso è la prima forma storica di «
scolastica », e cioè di utilizzazione sistematica della filosofia al servizio della
rivelazione religiosa. Fondatore del neoplatonismo è considerato dalla tradizione
Ammonio Sacca, che insegnò ad Alessandria nella prima metà del III see.; il maggior
rappresentante (e il vero fondatore della scuola, dal punto di vista sistematico) fu
Plotino di Licopoli, le cui lezioni furono pubblicate da Porfirio col titolo di
Enneadi*. Giamblico di Calcide (secc. III-IV), scolaro di Porfirio, fondò il