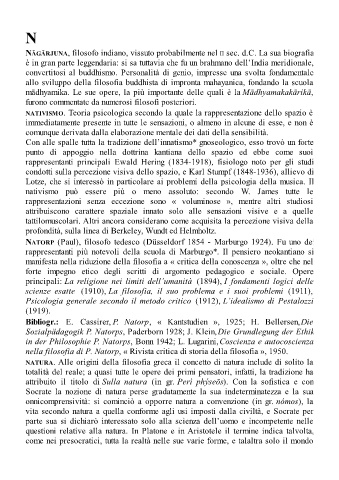Page 588 - Dizionario di Filosofia
P. 588
N
NĀGĀRJUNA, filosofo indiano, vissuto probabilmente nel II sec. d.C. La sua biografia
è in gran parte leggendaria: si sa tuttavia che fu un brahmano dell’India meridionale,
convertitosi al buddhismo. Personalità di genio, impresse una svolta fondamentale
allo sviluppo della filosofia buddhista di impronta mahayanica, fondando la scuola
mādhyamika. Le sue opere, la più importante delle quali è la Mādhyamakakārikā,
furono commentate da numerosi filosofi posteriori.
NATIVISMO. Teoria psicologica secondo la quale la rappresentazione dello spazio è
immediatamente presente in tutte le sensazioni, o almeno in alcune di esse, e non è
comunque derivata dalla elaborazione mentale dei dati della sensibilità.
Con alle spalle tutta la tradizione dell’innatismo* gnoseologico, esso trovò un forte
punto di appoggio nella dottrina kantiana dello spazio ed ebbe come suoi
rappresentanti principali Ewald Hering (1834-1918), fisiologo noto per gli studi
condotti sulla percezione visiva dello spazio, e Karl Stumpf (1848-1936), allievo di
Lotze, che si interessò in particolare ai problemi della psicologia della musica. Il
nativismo può essere più o meno assoluto: secondo W. James tutte le
rappresentazioni senza eccezione sono « voluminose », mentre altri studiosi
attribuiscono carattere spaziale innato solo alle sensazioni visive e a quelle
tattilomuscolari. Altri ancora considerano come acquisita la percezione visiva della
profondità, sulla linea di Berkeley, Wundt ed Helmholtz.
NATORP (Paul), filosofo tedesco (Düsseldorf 1854 - Marburgo 1924). Fu uno dei
rappresentanti più notevoli della scuola di Marburgo*. Il pensiero neokantiano si
manifesta nella riduzione della filosofia a « critica della conoscenza », oltre che nel
forte impegno etico degli scritti di argomento pedagogico e sociale. Opere
principali: La religione nei limiti dell’umanità (1894), I fondamenti logici delle
scienze esatte (1910), La filosofia, il suo problema e i suoi problemi (1911),
Psicologia generale secondo il metodo critico (1912), L’idealismo di Pestalozzi
(1919).
Bibliogr.: E. Cassirer, P. Natorp, « Kantstudien », 1925; H. Bellersen, Die
Sozialpädagogik P. Natorps, Paderborn 1928; J. Klein, Die Grundlegung der Ethik
in der Philosophie P. Natorps, Bonn 1942; L. Lugarini, Coscienza e autocoscienza
nella filosofia di P. Natorp, « Rivista critica di storia della filosofia », 1950.
NATURA. Alle origini della filosofia greca il concetto di natura include di solito la
totalità del reale; a quasi tutte le opere dei primi pensatori, infatti, la tradizione ha
attribuito il titolo di Sulla natura (in gr. Perì phýseōs). Con la sofistica e con
Socrate la nozione di natura perse gradatamente la sua indeterminatezza e la sua
onnicomprensività: si cominciò a opporre natura a convenzione (in gr. nómos), la
vita secondo natura a quella conforme agli usi imposti dalla civiltà, e Socrate per
parte sua si dichiarò interessato solo alla scienza dell’uomo e incompetente nelle
questioni relative alla natura. In Platone e in Aristotele il termine indica talvolta,
come nei presocratici, tutta la realtà nelle sue varie forme, e talaltra solo il mondo