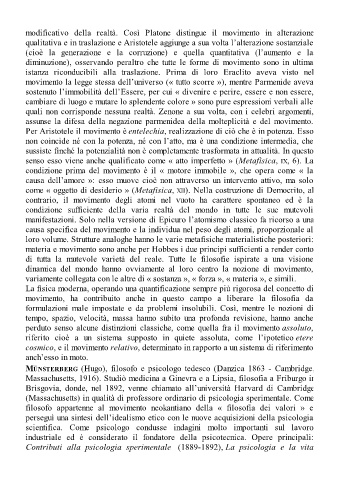Page 586 - Dizionario di Filosofia
P. 586
modificativo della realtà. Così Platone distingue il movimento in alterazione
qualitativa e in traslazione e Aristotele aggiunge a sua volta l’alterazione sostanziale
(cioè la generazione e la corruzione) e quella quantitativa (l’aumento e la
diminuzione), osservando peraltro che tutte le forme di movimento sono in ultima
istanza riconducibili alla traslazione. Prima di loro Eraclito aveva visto nel
movimento la legge stessa dell’universo (« tutto scorre »), mentre Parmenide aveva
sostenuto l’immobilità dell’Essere, per cui « divenire e perire, essere e non essere,
cambiare di luogo e mutare lo splendente colore » sono pure espressioni verbali alle
quali non corrisponde nessuna realtà. Zenone a sua volta, con i celebri argomenti,
assunse la difesa della negazione parmenidea della molteplicità e del movimento.
Per Aristotele il movimento è entelechia, realizzazione di ciò che è in potenza. Esso
non coincide né con la potenza, né con l’atto, ma è una condizione intermedia, che
sussiste finché la potenzialità non è completamente trasformata in attualità. In questo
senso esso viene anche qualificato come « atto imperfetto » (Metafìsica, IX, 6). La
condizione prima del movimento è il « motore immobile », che opera come « la
causa dell’amore »: esso muove cioè non attraverso un intervento attivo, ma solo
come « oggetto di desiderio » (Metafisica, XII). Nella costruzione di Democrito, al
contrario, il movimento degli atomi nel vuoto ha carattere spontaneo ed è la
condizione sufficiente della varia realtà del mondo in tutte le sue mutevoli
manifestazioni. Solo nella versione di Epicuro l’atomismo classico fa ricorso a una
causa specifica del movimento e la individua nel peso degli atomi, proporzionale al
loro volume. Strutture analoghe hanno le varie metafisiche materialistiche posteriori:
materia e movimento sono anche per Hobbes i due principi sufficienti a render conto
di tutta la mutevole varietà del reale. Tutte le filosofie ispirate a una visione
dinamica del mondo hanno ovviamente al loro centro la nozione di movimento,
variamente collegata con le altre di « sostanza », « forza », « materia », e simili.
La fìsica moderna, operando una quantificazione sempre più rigorosa del concetto di
movimento, ha contribuito anche in questo campo a liberare la filosofia da
formulazioni male impostate e da problemi insolubili. Così, mentre le nozioni di
tempo, spazio, velocità, massa hanno subito una profonda revisione, hanno anche
perduto senso alcune distinzioni classiche, come quella fra il movimento assoluto,
riferito cioè a un sistema supposto in quiete assoluta, come l’ipotetico etere
cosmico, e il movimento relativo, determinato in rapporto a un sistema di riferimento
anch’esso in moto.
MÜNSTERBERG (Hugo), filosofo e psicologo tedesco (Danzica 1863 - Cambridge,
Massachusetts, 1916). Studiò medicina a Ginevra e a Lipsia, filosofia a Friburgo in
Brisgovia, donde, nel 1892, venne chiamato all’università Harvard di Cambridge
(Massachusetts) in qualità di professore ordinario di psicologia sperimentale. Come
filosofo appartenne al movimento neokantiano della « filosofia dei valori » e
perseguì una sintesi dell’idealismo etico con le nuove acquisizioni della psicologia
scientifica. Come psicologo condusse indagini molto importanti sul lavoro
industriale ed è considerato il fondatore della psicotecnica. Opere principali:
Contributi alla psicologia sperimentale (1889-1892), La psicologia e la vita