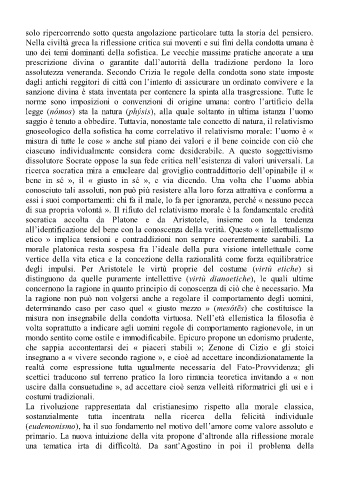Page 582 - Dizionario di Filosofia
P. 582
solo ripercorrendo sotto questa angolazione particolare tutta la storia del pensiero.
Nella civiltà greca la riflessione critica sui moventi e sui fini della condotta umana è
uno dei temi dominanti della sofistica. Le vecchie massime pratiche ancorate a una
prescrizione divina o garantite dall’autorità della tradizione perdono la loro
assolutezza veneranda. Secondo Crizia le regole della condotta sono state imposte
dagli antichi reggitori di città con l’intento di assicurare un ordinato convivere e la
sanzione divina è stata inventata per contenere la spinta alla trasgressione. Tutte le
norme sono imposizioni o convenzioni di origine umana: contro l’artificio della
legge (nómos) sta la natura (phýsis), alla quale soltanto in ultima istanza l’uomo
saggio è tenuto a obbedire. Tuttavia, nonostante tale concetto di natura, il relativismo
gnoseologico della sofistica ha come correlativo il relativismo morale: l’uomo è «
misura di tutte le cose » anche sul piano dei valori e il bene coincide con ciò che
ciascuno individualmente considera come desiderabile. A questo soggettivismo
dissolutore Socrate oppose la sua fede critica nell’esistenza di valori universali. La
ricerca socratica mira a enucleare dal groviglio contraddittorio dell’opinabile il «
bene in sé », il « giusto in sé », e via dicendo. Una volta che l’uomo abbia
conosciuto tali assoluti, non può più resistere alla loro forza attrattiva e conforma a
essi i suoi comportamenti: chi fa il male, lo fa per ignoranza, perché « nessuno pecca
di sua propria volontà ». Il rifiuto del relativismo morale è la fondamentale eredità
socratica accolta da Platone e da Aristotele, insieme con la tendenza
all’identificazione del bene con la conoscenza della verità. Questo « intellettualismo
etico » implica tensioni e contraddizioni non sempre coerentemente sanabili. La
morale platonica resta sospesa fra l’ideale della pura visione intellettuale come
vertice della vita etica e la concezione della razionalità come forza equilibratrice
degli impulsi. Per Aristotele le virtù proprie del costume (virtù etiche) si
distinguono da quelle puramente intellettive (virtù dianoetiche), le quali ultime
concernono la ragione in quanto principio di conoscenza di ciò che è necessario. Ma
la ragione non può non volgersi anche a regolare il comportamento degli uomini,
determinando caso per caso quel « giusto mezzo » (mesótēs) che costituisce la
misura non insegnabile della condotta virtuosa. Nell’età ellenistica la filosofia è
volta soprattutto a indicare agli uomini regole di comportamento ragionevole, in un
mondo sentito come ostile e immodificabile. Epicuro propone un edonismo prudente,
che sappia accontentarsi dei « piaceri stabili »; Zenone di Cizio e gli stoici
insegnano a « vivere secondo ragione », e cioè ad accettare incondizionatamente la
realtà come espressione tutta ugualmente necessaria del Fato-Provvidenza; gli
scettici traducono sul terreno pratico la loro rinuncia teoretica invitando a « non
uscire dalla consuetudine », ad accettare cioè senza velleità riformatrici gli usi e i
costumi tradizionali.
La rivoluzione rappresentata dal cristianesimo rispetto alla morale classica,
sostanzialmente tutta incentrata nella ricerca della felicità individuale
(eudemonismo), ha il suo fondamento nel motivo dell’amore come valore assoluto e
primario. La nuova intuizione della vita propone d’altronde alla riflessione morale
una tematica irta di difficoltà. Da sant’Agostino in poi il problema della