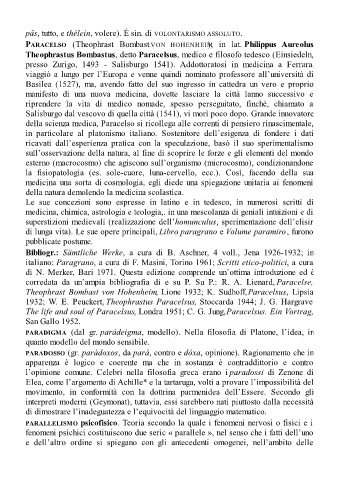Page 624 - Dizionario di Filosofia
P. 624
pâs, tutto, e thélein, volere). È sin. di VOLONTARISMO ASSOLUTO.
PARACELSO (Theophrast Bombast VON HOHENHEIM), in lat. Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus, detto Paracelsus, medico e filosofo tedesco (Einsiedeln,
presso Zurigo, 1493 - Salisburgo 1541). Addottoratosi in medicina a Ferrara,
viaggiò a lungo per l’Europa e venne quindi nominato professore all’università di
Basilea (1527), ma, avendo fatto del suo ingresso in cattedra un vero e proprio
manifesto di una nuova medicina, dovette lasciare la città lanno successivo e
riprendere la vita di medico nomade, spesso perseguitato, finché, chiamato a
Salisburgo dal vescovo di quella città (1541), vi morì poco dopo. Grande innovatore
della scienza medica, Paracelso si ricollega alle correnti di pensiero rinascimentale,
in particolare al platonismo italiano. Sostenitore dell’esigenza di fondere i dati
ricavati dall’esperienza pratica con la speculazione, basò il suo sperimentalismo
sull’osservazione della natura, al fine di scoprire le forze e gli elementi del mondo
esterno (macrocosmo) che agiscono sull’organismo (microcosmo), condizionandone
la fisiopatologia (es. sole-cuore, luna-cervello, ecc.). Così, facendo della sua
medicina una sorta di cosmologia, egli diede una spiegazione unitaria ai fenomeni
della natura demolendo la medicina scolastica.
Le sue concezioni sono espresse in latino e in tedesco, in numerosi scritti di
medicina, chimica, astrologia e teologia,. in una mescolanza di geniali intuizioni e di
superstizioni medievali (realizzazione dell’homunculus, sperimentazione dell’elisir
di lunga vita). Le sue opere principali, Libro paragrano e Volume paramiro, furono
pubblicate postume.
Bibliogr.: Sämtliche Werke, a cura di B. Aschner, 4 voll., Jena 1926-1932; in
italiano: Paragrano, a cura di F. Masini, Torino 1961; Scritti etico-politici, a cura
di N. Merker, Bari 1971. Questa edizione comprende un’ottima introduzione ed è
corredata da un’ampia bibliografia di e su P. Su P.: R. A. Lienard, Paracelse,
Theophrast Bombast von Hohenheim, Lione 1932; K. Sudhoff, Paracelsus, Lipsia
1932; W. E. Peuckert, Theophrastus Paracelsus, Stoccarda 1944; J. G. Hargrave,
The life and soul of Paracelsus, Londra 1951; C. G. Jung, Paracelsus. Ein Vortrag,
San Gallo 1952.
PARADIGMA (dal gr. parádeigma, modello). Nella filosofia di Platone, l’idea, in
quanto modello del mondo sensibile.
PARADOSSO (gr. parádoxos, da pará, contro e dóxa, opinione). Ragionamento che in
apparenza è logico e coerente ma che in sostanza è contraddittorio e contro
l’opinione comune. Celebri nella filosofia greca erano i paradossi di Zenone di
Elea, come l’argomento di Achille* e la tartaruga, volti a provare l’impossibilità del
movimento, in conformità con la dottrina parmenidea dell’Essere. Secondo gli
interpreti moderni (Geymonat), tuttavia, essi sarebbero nati piuttosto dalla necessità
di dimostrare l’inadeguatezza e l’equivocità del linguaggio matematico.
PARALLELISMO psicofisico. Teoria secondo la quale i fenomeni nervosi o fisici e i
fenomeni psichici costituiscono due seric « parallele », nel senso che i fatti dell’uno
e dell’altro ordine si spiegano con gli antecedenti omogenei, nell’ambito delle