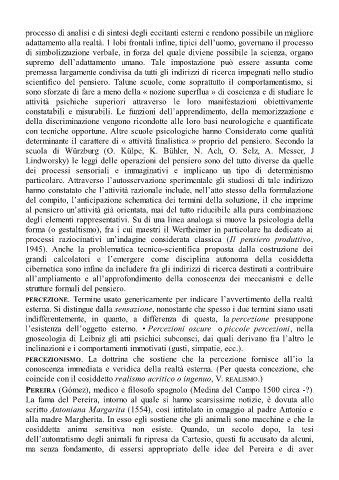Page 635 - Dizionario di Filosofia
P. 635
processo di analisi e di sintesi degli eccitanti esterni e rendono possibile un migliore
adattamento alla realtà. 1 lobi frontali infine, tipici dell’uomo, governano il processo
di simbolizzazione verbale, in forza del quale diviene possibile la scienza, organo
supremo dell’adattamento umano. Tale impostazione può essere assunta come
premessa largamente condivisa da tutti gli indirizzi di ricerca impegnati nello studio
scientifico del pensiero. Talune scuole, come soprattutto il comportamentismo, si
sono sforzate di fare a meno della « nozione superflua » di coscienza e di studiare le
attività psichiche superiori attraverso le loro manifestazioni obiettivamente
constatabili e misurabili. Le funzioni dell’apprendimento, della memorizzazione e
della discriminazione vengono ricondotte alle loro basi neurologiche e quantificate
con tecniche opportune. Altre scuole psicologiche hanno Considerato come qualità
determinante il carattere di « attività finalistica » proprio del pensiero. Secondo la
scuola di Würzburg (O. Külpe, K. Bühler, N. Ach, O. Selz, A. Messer, J.
Lindworsky) le leggi delle operazioni del pensiero sono del tutto diverse da quelle
dei processi sensoriali e immaginativi e implicano un tipo di determinismo
particolare. Attraverso l’autosservazione sperimentale gli studiosi di tale indirizzo
hanno constatato che l’attività razionale include, nell’atto stesso della formulazione
del compito, l’anticipazione schematica dei termini della soluzione, il che imprime
al pensiero un’attività già orientata, mai del tutto riducibile alla pura combinazione
degli elementi rappresentativi. Su di una linea analoga si muove la psicologia della
forma (o gestaltismo), fra i cui maestri il Wertheimer in particolare ha dedicato ai
processi raziocinativi un’indagine considerata classica (Il pensiero produttivo,
1945). Anche la problematica tecnico-scientifica proposta dalla costruzione dei
grandi calcolatori e l’emergere come disciplina autonoma della cosiddetta
cibernetica sono infine da includere fra gli indirizzi di ricerca destinati a contribuire
all’ampliamento e all’approfondimento della conoscenza dei meccanismi e delle
strutture formali del pensiero.
PERCEZIONE. Termine usato genericamente per indicare l’avvertimento della realtà
esterna. Si distingue dalla sensazione, nonostante che spesso i due termini siano usati
indifferentemente, in quanto, a differenza di questa, la percezione presuppone
l’esistenza dell’oggetto esterno. • Percezioni oscure o piccole percezioni, nella
gnoseologia di Leibniz gli atti psichici subconsci, dai quali derivano fra l’altro le
inclinazioni e i comportamenti immotivati (gusti, simpatie, ecc.).
PERCEZIONISMO. La dottrina che sostiene che la percezione fornisce all’io la
conoscenza immediata e veridica della realtà esterna. (Per questa concezione, che
coincide con il cosiddetto realismo acritico o ingenuo, V. REALISMO.)
PEREIRA (Gómez), medico e filosofo spagnolo (Medina del Campo 1500 circa -?).
La fama del Pereira, intorno al quale si hanno scarsissime notizie, è dovuta allo
scritto Antoniana Margarita (1554), così intitolato in omaggio al padre Antonio e
alla madre Margherita. In esso egli sostiene che gli animali sono macchine e che la
cosiddetta anima sensitiva non esiste. Quando, un secolo dopo, la tesi
dell’automatismo degli animali fu ripresa da Cartesio, questi fu accusato da alcuni,
ma senza fondamento, di essersi appropriato delle idee del Pereira e di aver