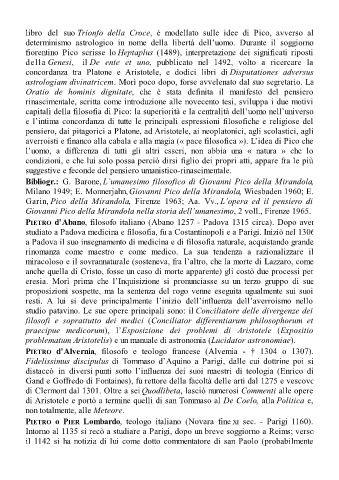Page 641 - Dizionario di Filosofia
P. 641
libro del suo Trionfo della Croce, è modellato sulle idee di Pico, avverso al
determinismo astrologico in nome della libertà dell’uomo. Durante il soggiorno
fiorentino Pico scrisse lo Heptaplus (1489), interpretazione dei significati riposti
della Genesi, il De ente et uno, pubblicato nel 1492, volto a ricercare la
concordanza tra Platone e Aristotele, e dodici libri di Disputationes adversus
astrologiam divinatricem. Morì poco dopo, forse avvelenato dal suo segretario. La
Oratio de hominis dignitate, che è stata definita il manifesto del pensiero
rinascimentale, scritta come introduzione alle novecento tesi, sviluppa i due motivi
capitali della filosofia di Pico: la superiorità e la centralità dell’uomo nell’universo
e l’intima concordanza di tutte le principali espressioni filosofiche e religiose del
pensiero, dai pitagorici a Platone, ad Aristotele, ai neoplatonici, agli scolastici, agli
averroisti e financo alla cabala e alla magia (« pace filosofica »). L’idea di Pico che
l’uomo, a differenza di tutti gli altri esseri, non abbia una « natura » che lo
condizioni, e che lui solo possa perciò dirsi figlio dei propri atti, appare fra le più
suggestive e feconde del pensiero umanistico-rinascimentale.
Bibliogr.: G. Barone, L’umanesimo filosofico di Giovanni Pico della Mirandola,
Milano 1949; E. Monnerjahn, Giovanni Pico della Mirandola, Wiesbaden 1960; E.
Garin, Pico della Mirandola, Firenze 1963; Aa. Vv., L’opera ed il pensiero di
Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell’umanesimo, 2 voll., Firenze 1965.
PIETRO d’Abano, filosofo italiano (Abano 1257 - Padova 1315 circa). Dopo aver
studiato a Padova medicina e filosofia, fu a Costantinopoli e a Parigi. Iniziò nel 1306
a Padova il suo insegnamento di medicina e di filosofia naturale, acquistando grande
rinomanza come maestro e come medico. La sua tendenza a razionalizzare il
miracoloso e il sovrannaturale (sosteneva, fra l’altro, che la morte di Lazzaro, come
anche quella di Cristo, fosse un caso di morte apparente) gli costò due processi per
eresia. Morì prima che l’Inquisizione si pronunciasse su un terzo gruppo di sue
proposizioni sospette, ma la sentenza del rogo venne eseguita ugualmente sui suoi
resti. A lui si deve principalmente l’inizio dell’influenza dell’averroismo nello
studio patavino. Le sue opere principali sono: il Conciliatore delle divergenze dei
filosofi e soprattutto dei medici (Conciliator differentiarum philosophorum et
praecipue medicorum), l’Esposizione dei problemi di Aristotele (Expositio
problematum Aristotelis) e un manuale di astronomia (Lucidator astronomiae).
PIETRO d’Alvernia, filosofo e teologo francese (Alvemia - † 1304 o 1307).
Fidelissimus discipulus di Tommaso d’Aquino a Parigi, dalle cui dottrine poi si
distaccò in diversi punti sotto l’influenza dei suoi maestri di teologia (Enrico di
Gand e Goffredo di Fontaines), fu rettore della facoltà delle arti dal 1275 e vescovo
di Clermont dal 1301. Oltre a sei Quodlibeta, lasciò numerosi Commenti alle opere
di Aristotele e portò a termine quelli di san Tommaso al De Coelo, alla Politica e,
non totalmente, alle Meteore.
PIETRO o PIER Lombardo, teologo italiano (Novara fine XI sec. - Parigi 1160).
Intorno al 1135 si recò a studiare a Parigi, dopo un breve soggiorno a Reims; verso
il 1142 si ha notizia di lui come dotto commentatore di san Paolo (probabilmente