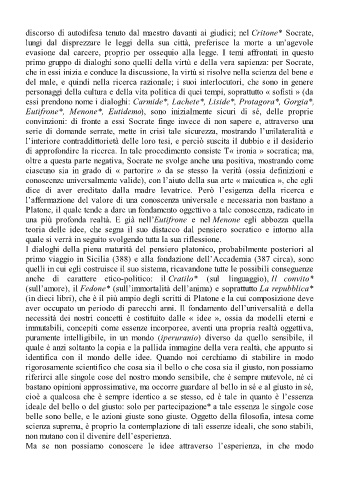Page 646 - Dizionario di Filosofia
P. 646
discorso di autodifesa tenuto dal maestro davanti ai giudici; nel Critone* Socrate,
lungi dal disprezzare le leggi della sua città, preferisce la morte a un’agevole
evasione dal carcere, proprio per ossequio alla legge. I temi affrontati in questo
primo gruppo di dialoghi sono quelli della virtù e della vera sapienza: per Socrate,
che in essi inizia e conduce la discussione, la virtù si risolve nella scienza del bene e
del male, e quindi nella ricerca razionale; i suoi interlocutori, che sono in genere
personaggi della cultura e della vita politica di quei tempi, soprattutto « sofisti » (da
essi prendono nome i dialoghi: Carmide*, Lachete*, Liside*, Protagora*, Gorgia*,
Eutifrone*, Menone*, Eutidemo), sono inizialmente sicuri di sé, delle proprie
convinzioni: di fronte a essi Socrate finge invece di non sapere e, attraverso una
serie di domande serrate, mette in crisi tale sicurezza, mostrando l’unilateralità e
l’interiore contraddittorietà delle loro tesi, e perciò suscita il dubbio e il desiderio
di approfondire la ricerca. In tale procedimento consiste T« ironia » socratica; ma,
oltre a questa parte negativa, Socrate ne svolge anche una positiva, mostrando come
ciascuno sia in grado di « partorire » da se stesso la verità (ossia definizioni e
conoscenze universalmente valide), con l’aiuto della sua arte « maieutica », che egli
dice di aver ereditato dalla madre levatrice. Però l’esigenza della ricerca e
l’affermazione del valore di una conoscenza universale e necessaria non bastano a
Platone, il quale tende a dare un fondamento oggettivo a tale conoscenza, radicato in
una più profonda realtà. E già nell’Eutifrone e nel Menone egli abbozza quella
teoria delle idee, che segna il suo distacco dal pensiero socratico e intorno alla
quale si verrà in seguito svolgendo tutta la sua riflessione.
I dialoghi della piena maturità del pensiero platonico, probabilmente posteriori al
primo viaggio in Sicilia (388) e alla fondazione dell’Accademia (387 circa), sono
quelli in cui egli costruisce il suo sistema, ricavandone tutte le possibili conseguenze
anche di carattere etico-politico: il Cratilo* (sul linguaggio), Il convito*
(sull’amore), il Fedone* (sull’immortalità dell’anima) e soprattutto La repubblica*
(in dieci libri), che è il più ampio degli scritti di Platone e la cui composizione deve
aver occupato un periodo di parecchi anni. Il fondamento dell’universalità e della
necessità dei nostri concetti è costituito dalle « idee », ossia da modelli eterni e
immutabili, concepiti come essenze incorporee, aventi una propria realtà oggettiva,
puramente intelligibile, in un mondo (iperuranio) diverso da quello sensibile, il
quale è anzi soltanto la copia e la pallida immagine della vera realtà, che appunto si
identifica con il mondo delle idee. Quando noi cerchiamo di stabilire in modo
rigorosamente scientifico che cosa sia il bello o che cosa sia il giusto, non possiamo
riferirci alle singole cose del nostro mondo sensibile, che è sempre mutevole, né ci
bastano opinioni approssimative, ma occorre guardare al bello in sé e al giusto in sé,
cioè a qualcosa che è sempre identico a se stesso, ed è tale in quanto è l’essenza
ideale del bello o del giusto: solo per partecipazione* a tale essenza le singole cose
belle sono belle, e le azioni giuste sono giuste. Oggetto della filosofia, intesa come
scienza suprema, è proprio la contemplazione di tali essenze ideali, che sono stabili,
non mutano con il divenire dell’esperienza.
Ma se non possiamo conoscere le idee attraverso l’esperienza, in che modo