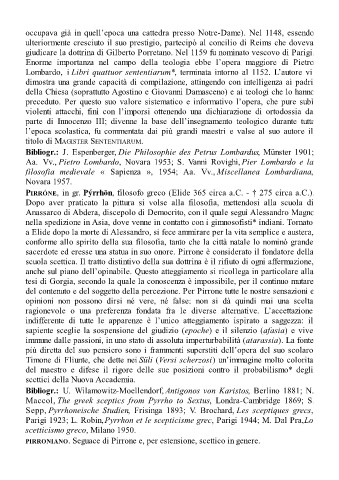Page 642 - Dizionario di Filosofia
P. 642
occupava già in quell’epoca una cattedra presso Notre-Dame). Nel 1148, essendo
ulteriormente cresciuto il suo prestigio, partecipò al concilio di Reims che doveva
giudicare la dottrina di Gilberto Porretano. Nel 1159 fu nominato vescovo di Parigi.
Enorme importanza nel campo della teologia ebbe l’opera maggiore di Pietro
Lombardo, i Libri quattuor sententiarum*, terminata intorno al 1152. L’autore vi
dimostra una grande capacità di compilazione, attingendo con intelligenza ai padri
della Chiesa (soprattutto Agostino e Giovanni Damasceno) e ai teologi che lo hanno
preceduto. Per questo suo valore sistematico e informativo l’opera, che pure subì
violenti attacchi, finì con l’imporsi ottenendo una dichiarazione di ortodossia da
parte di Innocenzo III; divenne la base dell’insegnamento teologico durante tutta
l’epoca scolastica, fu commentata dai più grandi maestri e valse al suo autore il
titolo di MAGISTER SENTENTIARUM.
Bibliogr.: J. Espenberger, Die Philosophie des Petrus Lombardus, Münster 1901;
Aa. Vv., Pietro Lombardo, Novara 1953; S. Vanni Rovighi, Pier Lombardo e la
filosofia medievale « Sapienza », 1954; Aa. Vv., Miscellanea Lombardiana,
Novara 1957.
PIRRÓNE, in gr. Pýrrhōn, filosofo greco (Elide 365 circa a.C. - † 275 circa a.C.).
Dopo aver praticato la pittura si volse alla filosofia, mettendosi alla scuola di
Anassarco di Abdera, discepolo di Democrito, con il quale seguì Alessandro Magno
nella spedizione in Asia, dove venne in contatto con i gimnosofisti* indiani. Tornato
a Elide dopo la morte di Alessandro, si fece ammirare per la vita semplice e austera,
conforme allo spirito della sua filosofia, tanto che la città natale lo nominò grande
sacerdote ed eresse una statua in suo onore. Pirrone è considerato il fondatore della
scuola scettica. Il tratto distintivo della sua dottrina è il rifiuto di ogni affermazione,
anche sul piano dell’opinabile. Questo atteggiamento si ricollega in particolare alla
tesi di Gorgia, secondo la quale la conoscenza è impossibile, per il continuo mutare
del contenuto e del soggetto della percezione. Per Pirrone tutte le nostre sensazioni e
opinioni non possono dirsi né vere, né false: non si dà quindi mai una scelta
ragionevole o una preferenza fondata fra le diverse alternative. L’accettazione
indifferente di tutte le apparenze è l’unico atteggiamento ispirato a saggezza: il
sapiente sceglie la sospensione del giudizio (epoche) e il silenzio (afasia) e vive
immune dalle passioni, in uno stato di assoluta imperturbabilità (atarassia). La fonte
più diretta del suo pensiero sono i frammenti superstiti dell’opera del suo scolaro
Timone di Fliunte, che dette nei Süli (Versi scherzosi) un’immagine molto colorita
del maestro e difese il rigore delle sue posizioni contro il probabilismo* degli
scettici della Nuova Accademia.
Bibliogr.: U. Wilamowitz-Moellendorf, Antigonos von Karistos, Berlino 1881; N.
Maccol, The greek sceptics from Pyrrho to Sextus, Londra-Cambridge 1869; S.
Sepp, Pyrrhoneische Studien, Frisinga 1893; V. Brochard, Les sceptiques grecs,
Parigi 1923; L. Robin, Pyrrhon et le scepticisme grec, Parigi 1944; M. Dal Pra, Lo
scetticismo greco, Milano 1950.
PIRRONIANO. Seguace di Pirrone e, per estensione, scettico in genere.