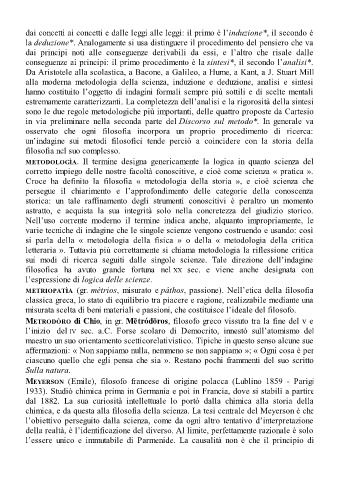Page 565 - Dizionario di Filosofia
P. 565
dai concetti ai concetti e dalle leggi alle leggi: il primo è l’induzione*, il secondo è
la deduzione*. Analogamente si usa distinguere il procedimento del pensiero che va
dai principi noti alle conseguenze derivabili da essi, e l’altro che risale dalle
conseguenze ai principi: il primo procedimento è la sintesi*, il secondo l’analisi*.
Da Aristotele alla scolastica, a Bacone, a Galileo, a Hume, a Kant, a J. Stuart Mill,
alla moderna metodologia della scienza, induzione e deduzione, analisi e sintesi
hanno costituito l’oggetto di indagini formali sempre più sottili e di scelte mentali
estremamente caratterizzanti. La completezza dell’analisi e la rigorosità della sintesi
sono le due regole metodologiche più importanti, delle quattro proposte da Cartesio
in via preliminare nella seconda parte del Discorso sul metodo*. In generale va
osservato che ogni filosofia incorpora un proprio procedimento di ricerca:
un’indagine sui metodi filosofici tende perciò a coincidere con la storia della
filosofia nel suo complesso.
METODOLOGÌA. Il termine designa genericamente la logica in quanto scienza del
corretto impiego delle nostre facoltà conoscitive, e cioè come scienza « pratica ».
Croce ha definito la filosofia « metodologia della storia », e cioè scienza che
persegue il chiarimento e l’approfondimento delle categorie della conoscenza
storica: un tale raffinamento degli strumenti conoscitivi è peraltro un momento
astratto, e acquista la sua integrità solo nella concretezza del giudizio storico.
Nell’uso corrente moderno il termine indica anche, alquanto impropriamente, le
varie tecniche di indagine che le singole scienze vengono costruendo e usando: così
si parla della « metodologia della fìsica » o della « metodologia della critica
letteraria ». Tuttavia più correttamente si chiama metodologia la riflessione critica
sui modi di ricerca seguiti dalle singole scienze. Tale direzione dell’indagine
filosofica ha avuto grande fortuna nel XX sec. e viene anche designata con
l’espressione di logica delle scienze.
METRIOPATÌA (gr. métrios, misurato e páthos, passione). Nell’etica della filosofia
classica greca, lo stato di equilibrio tra piacere e ragione, realizzabile mediante una
misurata scelta di beni materiali e passioni, che costituisce l’ideale del filosofo.
METRODÒRO di Chio, in gr. Mētródōros, filosofo greco vissuto tra la fine del v e
l’inizio del IV sec. a.C. Forse scolaro di Democrito, innestò sull’atomismo del
maestro un suo orientamento scetticorelativistico. Tipiche in questo senso alcune sue
affermazioni: « Non sappiamo nulla, nemmeno se non sappiamo »; « Ogni cosa è per
ciascuno quello che egli pensa che sia ». Restano pochi frammenti del suo scritto
Sulla natura.
MEYERSON (Emile), filosofo francese di origine polacca (Lublino 1859 - Parigi
1933). Studiò chimica prima in Germania e poi in Francia, dove si stabilì a partire
dal 1882. La sua curiosità intellettuale lo portò dalla chimica alla storia della
chimica, e da questa alla filosofia della scienza. La tesi centrale del Meyerson è che
l’obiettivo perseguito dalla scienza, come da ogni altro tentativo d’interpretazione
della realtà, è l’identificazione del diverso. Al limite, perfettamente razionale è solo
l’essere unico e immutabile di Parmenide. La causalità non è che il principio di