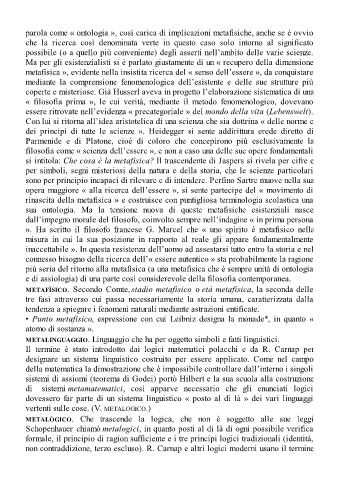Page 563 - Dizionario di Filosofia
P. 563
parola come « ontologia », così carica di implicazioni metafisiche, anche se è ovvio
che la ricerca così denominata verte in questo caso solo intorno al significato
possibile (o a quello più conveniente) degli asserti nell’ambito delle varie scienze.
Ma per gli esistenzialisti si è parlato giustamente di un « recupero della dimensione
metafìsica », evidente nella insistita ricerca del « senso dell’essere », da conquistare
mediante la comprensione fenomenologica dell’esistente e delle sue strutture più
coperte e misteriose. Già Husserl aveva in progetto l’elaborazione sistematica di una
« filosofia prima », le cui verità, mediante il metodo fenomenologico, dovevano
essere ritrovate nell’evidenza « precategoriale » del mondo della vita (Lebenswelt).
Con lui si ritorna all’idea aristotelica di una scienza che sia dottrina « delle norme e
dei principi di tutte le scienze ». Heidegger si sente addirittura erede diretto di
Parmenide e di Platone, cioè di coloro che concepirono più esclusivamente la
filosofia come « scienza dell’essere », e non a caso una delle sue opere fondamentali
si intitola: Che cosa è la metafisica? Il trascendente di Jaspers si rivela per cifre e
per simboli, segni misteriosi della natura e della storia, che le scienze particolari
sono per principio incapaci di rilevare e di intendere. Perfino Sartre muove nella sua
opera maggiore « alla ricerca dell’essere », si sente partecipe del « movimento di
rinascita della metafisica » e costruisce con puntigliosa terminologia scolastica una
sua ontologia. Ma la tensione nuova di queste metafisiche esistenziali nasce
dall’impegno morale del filosofo, coinvolto sempre nell’indagine « in prima persona
». Ha scritto il filosofo francese G. Marcel che « uno spirito è metafisico nella
misura in cui la sua posizione in rapporto al reale gli appare fondamentalmente
inaccettabile ». In questa resistenza dell’uomo ad assestarsi tutto entro la storia e nel
connesso bisogno della ricerca dell’« essere autentico » sta probabilmente la ragione
più seria del ritorno alla metafìsica (a una metafisica che è sempre unità di ontologia
e di assiologia) di una parte così considerevole della filosofia contemporanea.
METAFÌSICO. Secondo Comte, stadio metafisico o età metafisica, la seconda delle
tre fasi attraverso cui passa necessariamente la storia umana, caratterizzata dalla
tendenza a spiegare i fenomeni naturali mediante astrazioni entificate.
• Punto metafisico, espressione con cui Leibniz designa la monade*, in quanto «
atomo di sostanza ».
METALINGUAGGIO. Linguaggio che ha per oggetto simboli e fatti linguistici.
Il termine è stato introdotto dai logici matematici polacchi e da R. Carnap per
designare un sistema linguistico costruito per essere applicato. Come nel campo
della matematica la dimostrazione che è impossibile controllare dall’interno i singoli
sistemi di assiomi (teorema di Godei) portò Hilbert e la sua scuola alla costruzione
di sistemi metamatematici, così apparve necessario che gli enunciati logici
dovessero far parte di un sistema linguistico « posto al di là » dei vari linguaggi
vertenti sulle cose. (V. METALOGICO.)
METALÒGICO. Che trascende la logica, che non è soggetto alle sue leggi
Schopenhauer chiamò metalogici, in quanto posti al di là di ogni possibile verifica
formale, il principio di ragion sufficiente e i tre principi logici tradizionali (identità,
non contraddizione, terzo escluso). R. Carnap e altri logici moderni usano il termine