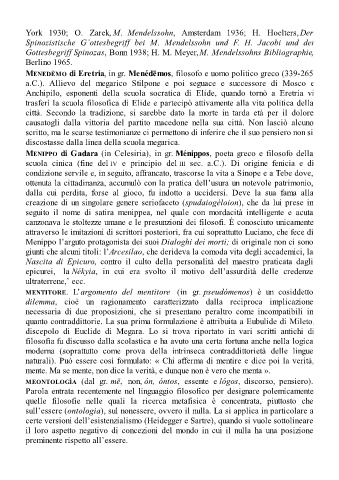Page 559 - Dizionario di Filosofia
P. 559
York 1930; O. Zarek, M. Mendelssohn, Amsterdam 1936; H. Hoelters, Der
Spinozistische G’ottesbegriff bei M. Mendelssohn und F. H. Jacobi und der
Gottesbegriff Spinozas, Bonn 1938; H. M. Meyer, M. Mendelssohns Bibliographie,
Berlino 1965.
MENEDÈMO di Eretria, in gr. Menédēmos, filosofo e uomo politico greco (339-265
a.C.). Allievo del megarico Stilpone e poi seguace e successore di Mosco e
Anchipilo, esponenti della scuola socratica di Elide, quando tornò a Eretria vi
trasferì la scuola filosofica di Elide e partecipò attivamente alla vita politica della
città. Secondo la tradizione, si sarebbe dato la morte in tarda età per il dolore
causatogli dalla vittoria del partito macedone nella sua città. Non lasciò alcuno
scritto, ma le scarse testimonianze ci permettono di inferire che il suo pensiero non si
discostasse dalla linea della scuola megarica.
MENIPPO di Gadara (in Celesiria), in gr. Ménippos, poeta greco e filosofo della
scuola cinica (fine del IV e principio del III sec. a.C.). Di origine fenicia e di
condizione servile e, in seguito, affrancato, trascorse la vita a Sinope e a Tebe dove,
ottenuta la cittadinanza, accumulò con la pratica dell’usura un notevole patrimonio,
dalla cui perdita, forse al gioco, fu indotto a uccidersi. Deve la sua fama alla
creazione di un singolare genere seriofaceto (spudaiogéloion), che da lui prese in
seguito il nome di satira menippea, nel quale con mordacità intelligente e acuta
canzonava le stoltezze umane e le presunzioni dei filosofi. È conosciuto unicamente
attraverso le imitazioni di scrittori posteriori, fra cui soprattutto Luciano, che fece di
Menippo l’arguto protagonista dei suoi Dialoghi dei morti; di originale non ci sono
giunti che alcuni titoli: l’Arcesilao, che derideva la comoda vita degli accademici, la
Nascita di Epicuro, contro il culto della personalità del maestro praticata dagli
epicurei, la Nékyia, in cui era svolto il motivo dell’assurdità delle credenze
ultraterrene,’ ecc.
MENTITORE. L’argomento del mentitore (in gr. pseudómenos) è un cosiddetto
dilemma, cioè un ragionamento caratterizzato dalla reciproca implicazione
necessaria di due proposizioni, che si presentano peraltro come incompatibili in
quanto contraddittorie. La sua prima formulazione è attribuita a Eubulide di Mileto,
discepolo di Euclide di Megara. Lo si trova riportato in vari scritti antichi di
filosofìa fu discusso dalla scolastica e ha avuto una certa fortuna anche nella logica
moderna (soprattutto come prova della intrinseca contraddittorietà delle lingue
naturali). Può essere così formulato: « Chi afferma di mentire e dice poi la verità,
mente. Ma se mente, non dice la verità, e dunque non è vero che menta ».
MEONTOLOGÌA (dal gr. mē, non, ón, óntos, essente e lógos, discorso, pensiero).
Parola entrata recentemente nel linguaggio filosofico per designare polemicamente
quelle filosofie nelle quali la ricerca metafisica è concentrata, piuttosto che
sull’essere (ontologia), sul nonessere, ovvero il nulla. La si applica in particolare a
certe versioni dell’esistenzialismo (Heidegger e Sartre), quando si vuole sottolineare
il loro aspetto negativo di concezioni del mondo in cui il nulla ha una posizione
preminente rispetto all’essere.