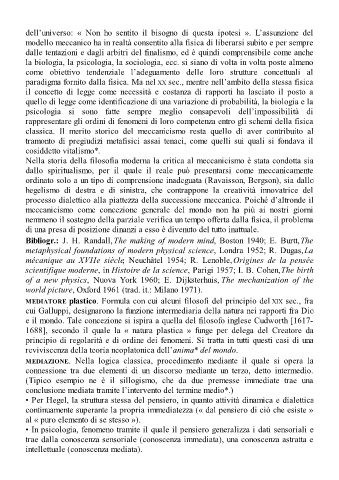Page 556 - Dizionario di Filosofia
P. 556
dell’universo: « Non ho sentito il bisogno di questa ipotesi ». L’assunzione del
modello meccanico ha in realtà consentito alla fisica di liberarsi subito e per sempre
dalle tentazioni e dagli arbitri del finalismo, ed è quindi comprensibile come anche
la biologia, la psicologia, la sociologia, ecc. si siano di volta in volta poste almeno
come obiettivo tendenziale l’adeguamento delle loro strutture concettuali al
paradigma fornito dalla fisica. Ma nel XX sec., mentre nell’ambito della stessa fisica
il concetto di legge come necessità e costanza di rapporti ha lasciato il posto a
quello di legge come identificazione di una variazione di probabilità, la biologia e la
psicologia si sono fatte sempre meglio consapevoli dell’impossibilità di
rappresentare gli ordini di fenomeni di loro competenza entro gli schemi della fisica
classica. Il merito storico del meccanicismo resta quello di aver contribuito al
tramonto di pregiudizi metafisici assai tenaci, come quelli sui quali si fondava il
cosiddetto vitalismo*.
Nella storia della filosofia moderna la critica al meccanicismo è stata condotta sia
dallo spiritualismo, per il quale il reale può presentarsi come meccanicamente
ordinato solo a un tipo di comprensione inadeguata (Ravaisson, Bergson), sia dallo
hegelismo di destra e di sinistra, che contrappone la creatività innovatrice del
processo dialettico alla piattezza della successione meccanica. Poiché d’altronde il
meccanicismo come concezione generale del mondo non ha più ai nostri giorni
nemmeno il sostegno della parziale verifica un tempo offerta dalla fìsica, il problema
di una presa di posizione dinanzi a esso è divenuto del tutto inattuale.
Bibliogr.: J. H. Randall, The making of modern mind, Boston 1940; E. Burtt, The
metaphysical foundations of modern physical science, Londra 1952; R. Dugas, La
mécanique au XVIIe siècle, Neuchâtel 1954; R. Lenoble, Origines de la pensée
scientifique moderne, in Histoire de la science, Parigi 1957; I. B. Cohen, The birth
of a new physics, Nuova York 1960; E. Dijksterhuis, The mechanization of the
world picture, Oxford 1961 (trad. it.: Milano 1971).
MEDIATORE plastico. Formula con cui alcuni filosofi del principio del XIX sec., fra
cui Galluppi, designarono la funzione intermediaria della natura nei rapporti fra Dio
e il mondo. Tale concezione si ispira a quella del filosofo inglese Cudworth [1617-
1688], secondo il quale la « natura plastica » funge per delega del Creatore da
principio di regolarità e di ordine dei fenomeni. Si tratta in tutti questi casi di una
reviviscenza della teoria neoplatonica dell’anima* del mondo.
MEDIAZIONE. Nella logica classica, procedimento mediante il quale si opera la
connessione tra due elementi di un discorso mediante un terzo, detto intermedio.
(Tipico esempio ne è il sillogismo, che da due premesse immediate trae una
conclusione mediata tramite l’intervento del termine medio*.)
• Per Hegel, la struttura stessa del pensiero, in quanto attività dinamica e dialettica
continuamente superante la propria immediatezza (« dal pensiero di ciò che esiste »
al « puro elemento di se stesso »).
• In psicologia, fenomeno tramite il quale il pensiero generalizza i dati sensoriali e
trae dalla conoscenza sensoriale (conoscenza immediata), una conoscenza astratta e
intellettuale (conoscenza mediata).