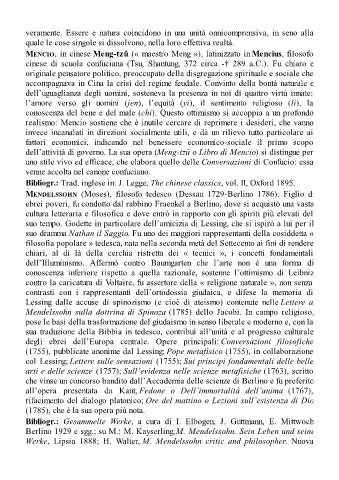Page 558 - Dizionario di Filosofia
P. 558
veramente. Essere e natura coincidono in una unità onnicomprensiva, in seno alla
quale le cose singole si dissolvono, nella loro effettiva realtà.
MENCIO, in cinese Meng-tzû (« maestro Meng »), latinizzato in Mencius, filosofo
cinese di scuola confuciana (Tsu, Shantung, 372 circa -† 289 a.C.). Fu chiaro e
originale pensatore politico, preoccupato della disgregazione spirituale e sociale che
accompagnava in Cina la crisi del regime feudale. Convinto della bontà naturale e
dell’uguaglianza degli uomini, sosteneva la presenza in noi di quattro virtù innate:
l’amore verso gli uomini (jen), l’equità (yi), il sentimento religioso (li), la
conoscenza del bene e del male (chi). Questo ottimismo si accoppia a un profondo
realismo: Mencio sostiene che è inutile cercare di reprimere i desideri, che vanno
invece incanalati in direzioni socialmente utili, e dà un rilievo tutto particolare ai
fattori economici, indicando nel benessere economico-sociale il primo scopo
dell’attività di governo. La sua opera (Meng-tzû o Libro di Mencio) si distingue per
uno stile vivo ed efficace, che elabora quello delle Conversazioni di Confucio: essa
venne accolta nel canone confuciano.
Bibliogr.: Trad. inglese in: J. Legge, The chinese classics, vol. II, Oxford 1895.
MENDELSSOHN (Moses), filosofo tedesco (Dessau 1729-Berlino 1786). Figlio di
ebrei poveri, fu condotto dal rabbino Fraenkel a Berlino, dove si acquistò una vasta
cultura letteraria e filosofica e dove entrò in rapporto con gli spiriti più elevati del
suo tempo. Godette in particolare dell’amicizia di Lessing, che si ispirò a lui per il
suo dramma Nathan il Saggio. Fu uno dei maggiori rappresentanti della cosiddetta «
filosofia popolare » tedesca, nata nella seconda metà del Settecento ai fini di rendere
chiari, al di là della cerchia ristretta dei « tecnici », i concetti fondamentali
dell’Illuminismo. Affermò contro Baumgarten che l’arte non è una forma di
conoscenza inferiore rispetto a quella razionale, sostenne l’ottimismo di Leibniz
contro la caricatura di Voltaire, fu assertore della « religione naturale », non senza
contrasti con i rappresentanti dell’ortodossia giudaica, e difese la memoria di
Lessing dalle accuse di spinozismo (e cioè di ateismo) contenute nelle Lettere a
Mendelssohn sulla dottrina di Spinoza (1785) dello Jacobi. In campo religioso,
pose le basi della trasformazione del giudaismo in senso liberale e moderno e, con la
sua traduzione della Bibbia in tedesco, contribuì all’unità e al progresso culturale
degli ebrei dell’Europa centrale. Opere principali: Conversazioni filosofiche
(1755), pubblicate anonime dal Lessing; Pope metafisico (1755), in collaborazione
col Lessing; Lettere sulle sensazioni (1755); Sui principi fondamentali delle belle
arti e delle scienze (1757); Sull’evidenza nelle scienze metafisiche (1763), scritto
che vinse un concorso bandito dall’Accademia delle scienze di Berlino e fu preferito
all’opera presentata da Kant, Fedone o Dell’immortalità dell’anima (1767),
rifacimento del dialogo platonico; Ore del mattino o Lezioni sull’esistenza di Dio
(1785), che è la sua opera più nota.
Bibliogr.: Gesammelte Werke, a cura di I. Elbogen, J. Guttmann, E. Mittwoch,
Berlino 1929 e sgg.; su M.: M. Kayserling, M. Mendelssohn. Sein Leben und seine
Werke, Lipsia 1888; H. Walter, M. Mendelssohn critic and philosopher. Nuova