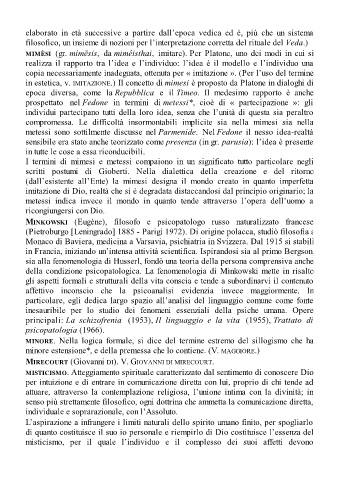Page 570 - Dizionario di Filosofia
P. 570
elaborato in età successive a partire dall’epoca vedica ed è, più che un sistema
filosofico, un insieme di nozioni per l’interpretazione corretta del rituale del Veda.)
MIMÈSI (gr. mímēsis, da mimêisthai, imitare). Per Platone, uno dei modi in cui si
realizza il rapporto tra l’idea e l’individuo: l’idea è il modello e l’individuo una
copia necessariamente inadeguata, ottenuta per « imitazione ». (Per l’uso del termine
in estetica, v. IMITAZIONE.) Il concetto di mimesi è proposto da Platone in dialoghi di
epoca diversa, come la Repubblica e il Timeo. Il medesimo rapporto è anche
prospettato nel Fedone in termini di metessi*, cioè di « partecipazione »: gli
individui partecipano tutti della loro idea, senza che l’unità di questa sia peraltro
compromessa. Le difficoltà insormontabili implicite sia nella mimesi sia nella
metessi sono sottilmente discusse nel Parmenide. Nel Fedone il nesso idea-realtà
sensibile era stato anche teorizzato come presenza (in gr. parusía): l’idea è presente
in tutte le cose a essa riconducibili.
I termini di mimesi e metessi compaiono in un significato tutto particolare negli
scritti postumi di Gioberti. Nella dialettica della creazione e del ritorno
(dall’esistente all’Ente) la mimesi designa il mondo creato in quanto imperfetta
imitazione di Dio, realtà che si è degradata distaccandosi dal principio originario; la
metessi indica invece il mondo in quanto tende attraverso l’opera dell’uomo a
ricongiungersi con Dio.
MINKOWSKI (Eugène), filosofo e psicopatologo russo naturalizzato francese
(Pietroburgo [Leningrado] 1885 - Parigi 1972). Di origine polacca, studiò filosofia a
Monaco di Baviera, medicina a Varsavia, psichiatria in Svizzera. Dal 1915 si stabilì
in Francia, iniziando un’intensa attività scientifica. Ispirandosi sia al primo Bergson,
sia alla fenomenologia di Husserl, fondò una teoria della persona comprensiva anche
della condizione psicopatologica. La fenomenologia di Minkowski mette in risalto
gli aspetti formali e strutturali della vita conscia e tende a subordinarvi il contenuto
affettivo inconscio che la psicoanalisi evidenzia invece maggiormente. In
particolare, egli dedica largo spazio all’analisi del linguaggio comune come fonte
inesauribile per lo studio dei fenomeni essenziali della psiche umana. Opere
principali: La schizofrenia (1953), Il linguaggio e la vita (1955), Trattato di
psicopatologia (1966).
MINORE. Nella logica formale, si dice del termine estremo del sillogismo che ha
minore estensione*, e della premessa che lo contiene. (V. MAGGIORE.)
MIRECOURT (Giovanni DI). V. GIOVANNI DI MIRECOURT.
MISTICISMO. Atteggiamento spirituale caratterizzato dal sentimento di conoscere Dio
per intuizione e di entrare in comunicazione diretta con lui, proprio di chi tende ad
attuare, attraverso la contemplazione religiosa, l’unione intima con la divinità; in
senso più strettamente filosofico, ogni dottrina che ammetta la comunicazione diretta,
individuale e soprarazionale, con l’Assoluto.
L’aspirazione a infrangere i limiti naturali dello spirito umano finito, per spogliarlo
di quanto costituisce il suo io personale e riempirlo di Dio costituisce l’essenza del
misticismo, per il quale l’individuo e il complesso dei suoi affetti devono