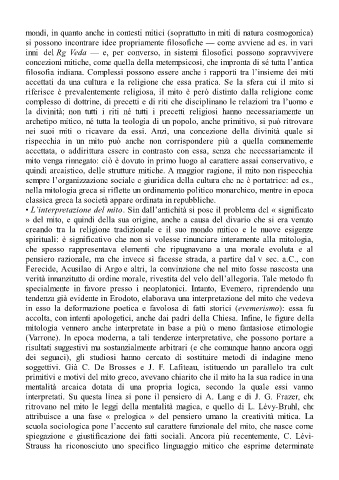Page 573 - Dizionario di Filosofia
P. 573
mondi, in quanto anche in contesti mitici (soprattutto in miti di natura cosmogonica)
si possono incontrare idee propriamente filosofiche — come avviene ad es. in vari
inni del Rg Veda — e, per converso, in sistemi filosofici possono sopravvivere
concezioni mitiche, come quella della metempsicosi, che impronta di sé tutta l’antica
filosofia indiana. Complessi possono essere anche i rapporti tra l’insieme dei miti
accettati da una cultura e la religione che essa pratica. Se la sfera cui il mito si
riferisce è prevalentemente religiosa, il mito è però distinto dalla religione come
complesso di dottrine, di precetti e di riti che disciplinano le relazioni tra l’uomo e
la divinità; non tutti i riti né tutti i precetti religiosi hanno necessariamente un
archetipo mitico, né tutta la teologia di un popolo, anche primitivo, si può ritrovare
nei suoi miti o ricavare da essi. Anzi, una concezione della divinità quale si
rispecchia in un mito può anche non corrispondere più a quella comunemente
accettata, o addirittura essere in contrasto con essa, senza che necessariamente il
mito venga rinnegato: ciò è dovuto in primo luogo al carattere assai conservativo, e
quindi arcaistico, delle strutture mitiche. A maggior ragione, il mito non rispecchia
sempre l’organizzazione sociale e giuridica della cultura che ne è portatrice: ad es.,
nella mitologia greca si riflette un ordinamento politico monarchico, mentre in epoca
classica greca la società appare ordinata in repubbliche.
• L’interpretazione del mito. Sin dall’antichità si pose il problema del « significato
» del mito, e quindi della sua origine, anche a causa del divario che si era venuto
creando tra la religione tradizionale e il suo mondo mitico e le nuove esigenze
spirituali: è significativo che non si volesse rinunciare interamente alla mitologia,
che spesso rappresentava elementi che ripugnavano a una morale evoluta e al
pensiero razionale, ma che invece sì facesse strada, a partire dal V sec. a.C., con
Ferecide, Acusilao di Argo e altri, la convinzione che nel mito fosse nascosta una
verità innanzitutto di ordine morale, rivestita del velo dell’allegoria. Tale metodo fu
specialmente in favore presso i neoplatonici. Intanto, Evemero, riprendendo una
tendenza già evidente in Erodoto, elaborava una interpretazione del mito che vedeva
in esso la deformazione poetica e favolosa di fatti storici (evemerismo): essa fu
accolta, con intenti apologetici, anche dai padri della Chiesa. Infine, le figure della
mitologia vennero anche interpretate in base a più o meno fantasiose etimologie
(Varrone). In epoca moderna, a tali tendenze interpretative, che possono portare a
risultati suggestivi ma sostanzialmente arbitrari (e che comunque hanno ancora oggi
dei seguaci), gli studiosi hanno cercato di sostituire metodi di indagine meno
soggettivi. Già C. De Brosses e J. F. Lafiteau, istituendo un parallelo tra culti
primitivi e motivi del mito greco, avevano chiarito che il mito ha la sua radice in una
mentalità arcaica dotata di una propria logica, secondo la quale essi vanno
interpretati. Su questa linea si pone il pensiero di A. Lang e di J. G. Frazer, che
ritrovano nel mito le leggi della mentalità magica, e quello di L. Lévy-Bruhl, che
attribuisce a una fase « prelogica » del pensiero umano la creatività mitica. La
scuola sociologica pone l’accento sul carattere funzionale del mito, che nasce come
spiegazione e giustificazione dei fatti sociali. Ancora più recentemente, C. Lévi-
Strauss ha riconosciuto uno specifico linguaggio mitico che esprime determinate