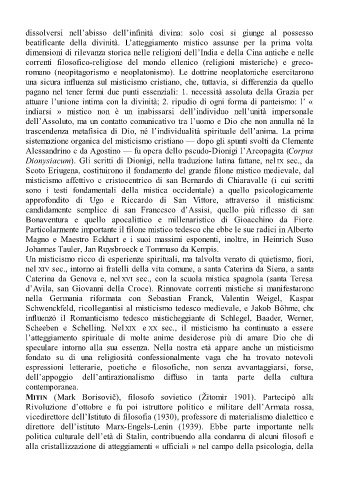Page 571 - Dizionario di Filosofia
P. 571
dissolversi nell’abisso dell’infinità divina: solo così si giunge al possesso
beatificante della divinità. L’atteggiamento mistico assunse per la prima volta
dimensioni di rilevanza storica nelle religioni dell’India e della Cina antiche e nelle
correnti filosofico-religiose del mondo ellenico (religioni misteriche) e greco-
romano (neopitagorismo e neoplatonismo). Le dottrine neoplatoniche esercitarono
una sicura influenza sul misticismo cristiano, che, tuttavia, si differenzia da quello
pagano nel tener fermi due punti essenziali: 1. necessità assoluta della Grazia per
attuare l’unione intima con la divinità; 2. ripudio di ogni forma di panteismo: l’ «
indiarsi » mistico non è un inabissarsi dell’individuo nell’unità impersonale
dell’Assoluto, ma un contatto comunicativo tra l’uomo e Dio che non annulla né la
trascendenza metafisica di Dio, né l’individualità spirituale dell’anima. La prima
sistemazione organica del misticismo cristiano — dopo gli spunti svolti da Clemente
Alessandrino e da Agostino — fu opera dello pseudo-Dionigi l’Areopagita (Corpus
Dionysiacum). Gli scritti di Dionigi, nella traduzione latina fattane, nel IX sec., da
Scoto Eriugena, costituirono il fondamento del grande filone mistico medievale, dal
misticismo affettivo e cristocentrico di san Bernardo di Chiaravalle (i cui scritti
sono i testi fondamentali della mistica occidentale) a quello psicologicamente
approfondito di Ugo e Riccardo di San Vittore, attraverso il misticismo
candidamente semplice di san Francesco d’Assisi, quello più riflesso di san
Bonaventura e quello apocalittico e millenaristico di Gioacchino da Fiore.
Particolarmente importante il filone mistico tedesco che ebbe le sue radici in Alberto
Magno e Maestro Eckhart e i suoi massimi esponenti, inoltre, in Heinrich Suso,
Johannes Tauler, Jan Ruysbroeck e Tommaso da Kempis.
Un misticismo ricco di esperienze spirituali, ma talvolta venato di quietismo, fiorì,
nel XIV sec., intorno ai fratelli della vita comune, a santa Caterina da Siena, a santa
Caterina da Genova e, nel XVI sec., con la scuola mistica spagnola (santa Teresa
d’Avila, san Giovanni della Croce). Rinnovate correnti mistiche si manifestarono
nella Germania riformata con Sebastian Franck, Valentin Weigel, Kaspar
Schwenckfeld, ricollegantisi al misticismo tedesco medievale, e Jakob Böhme, che
influenzò il Romanticismo tedesco misticheggiante di Schlegel, Baader, Werner,
Scheeben e Schelling. Nel XIX e XX sec., il misticismo ha continuato a essere
l’atteggiamento spirituale di molte anime desiderose più di amare Dio che di
speculare intorno alla sua essenza. Nella nostra età appare anche un misticismo
fondato su di una religiosità confessionalmente vaga che ha trovato notevoli
espressioni letterarie, poetiche e filosofiche, non senza avvantaggiarsi, forse,
dell’appoggio dell’antirazionalismo diffuso in tanta parte della cultura
contemporanea.
MITIN (Mark Borisovič), filosofo sovietico (Žitomir 1901). Partecipò alla
Rivoluzione d’ottobre e fu poi istruttore politico e militare dell’Armata rossa,
vicedirettore dell’Istituto di filosofia (1930), professore di materialismo dialettico e
direttore dell’istituto Marx-Engels-Lenin (1939). Ebbe parte importante nella
politica culturale dell’età di Stalin, contribuendo alla condanna di alcuni filosofi e
alla cristallizzazione di atteggiamenti « ufficiali » nel campo della psicologia, della