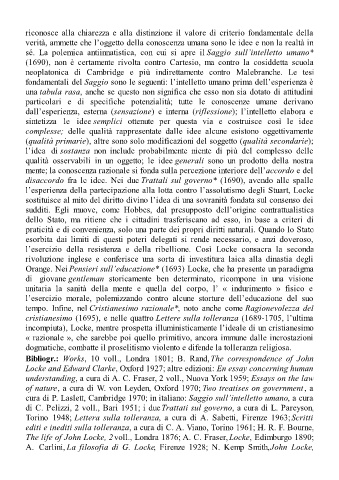Page 500 - Dizionario di Filosofia
P. 500
riconosce alla chiarezza e alla distinzione il valore di criterio fondamentale della
verità, ammette che l’oggetto della conoscenza umana sono le idee e non la realtà in
sé. La polemica antiinnatistica, con cui si apre il Saggio sull’intelletto umano*
(1690), non è certamente rivolta contro Cartesio, ma contro la cosiddetta scuola
neoplatonica di Cambridge e più indirettamente contro Malebranche. Le tesi
fondamentali del Saggio sono le seguenti: l’intelletto umano prima dell’esperienza è
una tabula rasa, anche se questo non significa che esso non sia dotato di attitudini
particolari e di specifiche potenzialità; tutte le conoscenze umane derivano
dall’esperienza, esterna (sensazione) e interna (riflessione); l’intelletto elabora e
sintetizza le idee semplici ottenute per questa via e costruisce così le idee
complesse; delle qualità rappresentate dalle idee alcune esistono oggettivamente
(qualità primarie), altre sono solo modificazioni del soggetto (qualità secondarie);
l’idea di sostanza non include probabilmente niente di più del complesso delle
qualità osservabili in un oggetto; le idee generali sono un prodotto della nostra
mente; la conoscenza razionale si fonda sulla percezione interiore dell’accordo e del
disaccordo fra le idee. Nei due Trattali sul governo* (1690), avendo alle spalle
l’esperienza della partecipazione alla lotta contro l’assolutismo degli Stuart, Locke
sostituisce al mito del diritto divino l’idea di una sovranità fondata sul consenso dei
sudditi. Egli muove, come Hobbes, dal presupposto dell’origine contrattualistica
dello Stato, ma ritiene che i cittadini trasferiscano ad esso, in base a criteri di
praticità e di convenienza, solo una parte dei propri diritti naturali. Quando lo Stato
esorbita dai limiti di questi poteri delegati si rende necessario, e anzi doveroso,
l’esercizio della resistenza e della ribellione. Così Locke consacra la seconda
rivoluzione inglese e conferisce una sorta di investitura laica alla dinastia degli
Orange. Nei Pensieri sull’educazione* (1693) Locke, che ha presente un paradigma
di giovane gentleman storicamente ben determinato, ricompone in una visione
unitaria la sanità della mente e quella del corpo, l’ « indurimento » fisico e
l’esercizio morale, polemizzando contro alcune storture dell’educazione del suo
tempo. Infine, nel Cristianesimo razionale*, noto anche come Ragionevolezza del
cristianesimo (1695), e nelle quattro Lettere sulla tolleranza (1689-1705, l’ultima
incompiuta), Locke, mentre prospetta illuministicamente l’ideale di un cristianesimo
« razionale », che sarebbe poi quello primitivo, ancora immune dalle incrostazioni
dogmatiche, combatte il proselitismo violento e difende la tolleranza religiosa.
Bibliogr.: Works, 10 voll., Londra 1801; B. Rand, The correspondence of John
Locke and Edward Clarke, Oxford 1927; altre edizioni: En essay concerning human
understanding, a cura di A. C. Fraser, 2 voll., Nuova York 1959; Essays on the law
of nature, a cura di W. von Leyden, Oxford 1970; Two treatises on government, a
cura di P. Laslett, Cambridge 1970; in italiano: Saggio sull’intelletto umano, a cura
di C. Pelizzi, 2 voll., Bari 1951; i due Trattati sul governo, a cura di L. Pareyson,
Torino 1948; Lettera sulla tolleranza, a cura di A. Sabetti, Firenze 1963; Scritti
editi e inediti sulla tolleranza, a cura di C. A. Viano, Torino 1961; H. R. F. Bourne,
The life of John Locke, 2 voll., Londra 1876; A. C. Fraser, Locke, Edimburgo 1890;
A. Carlini, La filosofia di G. Locke, Firenze 1928; N. Kemp Smith, John Locke,