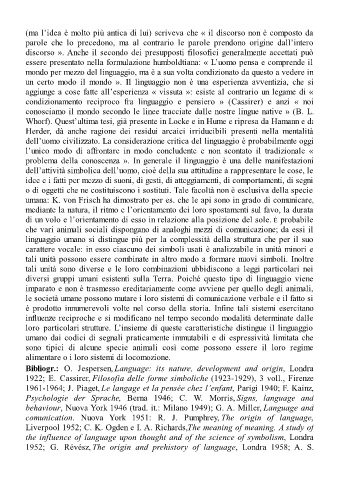Page 497 - Dizionario di Filosofia
P. 497
(ma l’idea è molto più antica di lui) scriveva che « il discorso non è composto da
parole che lo precedono, ma al contrario le parole prendono origine dall’intero
discorso ». Anche il secondo dei presupposti filosofici generalmente accettati può
essere presentato nella formulazione humboldtiana: « L’uomo pensa e comprende il
mondo per mezzo del linguaggio, ma è a sua volta condizionato da questo a vedere in
un certo modo il mondo ». Il linguaggio non è una esperienza avventizia, che si
aggiunge a cose fatte all’esperienza « vissuta »: esiste al contrario un legame di «
condizionamento reciproco fra linguaggio e pensiero » (Cassirer) e anzi « noi
conosciamo il mondo secondo le linee tracciate dalle nostre lingue native » (B. L.
Whorf). Quest’ultima tesi, già presente in Locke e in Hume e ripresa da Hamann e da
Herder, dà anche ragione dei residui arcaici irriducibili presenti nella mentalità
dell’uomo civilizzato. La considerazione critica del linguaggio è probabilmente oggi
l’unico modo di affrontare in modo concludente e non scontato il tradizionale «
problema della conoscenza ». In generale il linguaggio è una delle manifestazioni
dell’attività simbolica dell’uomo, cioè della sua attitudine a rappresentare le cose, le
idee e i fatti per mezzo di suoni, di gesti, di atteggiamenti, di comportamenti, di segni
o di oggetti che ne costituiscono i sostituti. Tale facoltà non è esclusiva della specie
umana: K. von Frisch ha dimostrato per es. che le api sono in grado di comunicare,
mediante la natura, il ritmo e l’orientamento dei loro spostamenti sul favo, la durata
di un volo e l’orientamento di esso in relazione alla posizione del sole. È probabile
che vari animali sociali dispongano di analoghi mezzi di comunicazione; da essi il
linguaggio umano si distingue più per la complessità della struttura che per il suo
carattere vocale: in esso ciascuno dei simboli usati è analizzabile in unità minori e
tali unità possono essere combinate in altro modo a formare nuovi simboli. Inoltre
tali unità sono diverse e le loro combinazioni ubbidiscono a leggi particolari nei
diversi gruppi umani esistenti sulla Terra. Poiché questo tipo di linguaggio viene
imparato e non è trasmesso ereditariamente come avviene per quello degli animali,
le società umane possono mutare i loro sistemi di comunicazione verbale e il fatto si
è prodotto innumerevoli volte nel corso della storia. Infine tali sistemi esercitano
influenze reciproche e si modificano nel tempo secondo modalità determinate dalle
loro particolari strutture. L’insieme di queste caratteristiche distingue il linguaggio
umano dai codici di segnali praticamente immutabili e di espressività limitata che
sono tipici di alcune specie animali così come possono essere il loro regime
alimentare o i loro sistemi di locomozione.
Bibliogr.: O. Jespersen, Language: its nature, development and origin, Londra
1922; E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1923-1929), 3 voll., Firenze
1961-1964; J. Piaget, Le langage et la pensée chez l’enfant, Parigi 1940; F. Kainz,
Psychologie der Sprache, Berna 1946; C. W. Morris, Signs, language and
behaviour, Nuova York 1946 (trad. it.: Milano 1949); G. A. Miller, Language and
comunication. Nuova York 1951: R. J. Pumphrey, The origin of language,
Liverpool 1952; C. K. Ogden e I. A. Richards, The meaning of meaning. A study of
the influence of language upon thought and of the science of symbolism, Londra
1952; G. Révész, The origin and prehistory of language, Londra 1958; A. S.