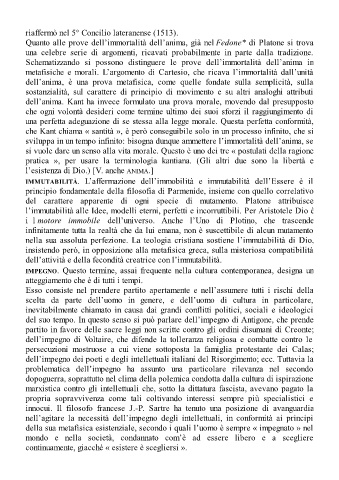Page 422 - Dizionario di Filosofia
P. 422
riaffermò nel 5° Concilio lateranense (1513).
Quanto alle prove dell’immortalità dell’anima, già nel Fedone* di Platone si trova
una celebre serie di argomenti, ricavati probabilmente in parte dalla tradizione.
Schematizzando si possono distinguere le prove dell’immortalità dell’anima in
metafisiche e morali. L’argomento di Cartesio, che ricava l’immortalità dall’unità
dell’anima, è una prova metafisica, come quelle fondate sulla semplicità, sulla
sostanzialità, sul carattere di principio di movimento e su altri analoghi attributi
dell’anima. Kant ha invece formulato una prova morale, movendo dal presupposto
che ogni volontà desideri come termine ultimo dei suoi sforzi il raggiungimento di
una perfetta adeguazione di se stessa alla legge morale. Questa perfetta conformità,
che Kant chiama « santità », è però conseguibile solo in un processo infinito, che si
sviluppa in un tempo infinito: bisogna dunque ammettere l’immortalità dell’anima, se
si vuole dare un senso alla vita morale. Questo è uno dei tre « postulati della ragione
pratica », per usare la terminologia kantiana. (Gli altri due sono la libertà e
l’esistenza di Dio.) [V. anche ANIMA.]
IMMUTABILITÀ. L’affermazione dell’immobilità e immutabilità dell’Essere è il
principio fondamentale della filosofia di Parmenide, insieme con quello correlativo
del carattere apparente di ogni specie di mutamento. Platone attribuisce
l’immutabilità alle Idee, modelli eterni, perfetti e incorruttibili. Per Aristotele Dio è
i l motore immobile dell’universo. Anche l’Uno di Plotino, che trascende
infinitamente tutta la realtà che da lui emana, non è suscettibile di alcun mutamento
nella sua assoluta perfezione. La teologia cristiana sostiene l’immutabilità di Dio,
insistendo però, in opposizione alla metafisica greca, sulla misteriosa compatibilità
dell’attività e della fecondità creatrice con l’immutabilità.
IMPEGNO. Questo termine, assai frequente nella cultura contemporanea, designa un
atteggiamento che è di tutti i tempi.
Esso consiste nel prendere partito apertamente e nell’assumere tutti i rischi della
scelta da parte dell’uomo in genere, e dell’uomo di cultura in particolare,
inevitabilmente chiamato in causa dai grandi conflitti politici, sociali e ideologici
del suo tempo. In questo senso si può parlare dell’impegno di Antigone, che prende
partito in favore delle sacre leggi non scritte contro gli ordini disumani di Creonte;
dell’impegno di Voltaire, che difende la tolleranza religiosa e combatte contro le
persecuzioni mostruose a cui viene sottoposta la famiglia protestante dei Calas;
dell’impegno dei poeti e degli intellettuali italiani del Risorgimento; ecc. Tuttavia la
problematica dell’impegno ha assunto una particolare rilevanza nel secondo
dopoguerra, soprattutto nel clima della polemica condotta dalla cultura di ispirazione
marxistica contro gli intellettuali che, sotto la dittatura fascista, avevano pagato la
propria sopravvivenza come tali coltivando interessi sempre più specialistici e
innocui. Il filosofo francese J.-P. Sartre ha tenuto una posizione di avanguardia
nell’agitare la necessità dell’impegno degli intellettuali, in conformità ai principi
della sua metafìsica esistenziale, secondo i quali l’uomo è sempre « impegnato » nel
mondo e nella società, condannato com’è ad essere libero e a scegliere
continuamente, giacché « esistere è scegliersi ».