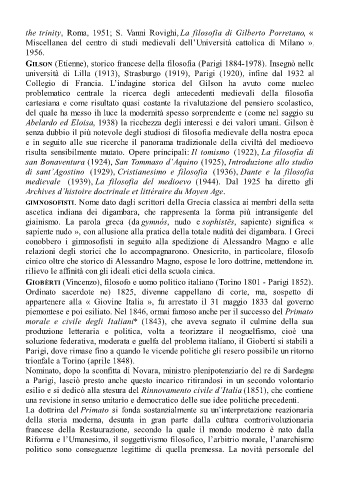Page 366 - Dizionario di Filosofia
P. 366
the trinity, Roma, 1951; S. Vanni Rovighi, La filosofia di Gilberto Porretano, «
Miscellanea del centro di studi medievali dell’Università cattolica di Milano »,
1956.
GILSON (Etienne), storico francese della filosofia (Parigi 1884-1978). Insegnò nelle
università di Lilla (1913), Strasburgo (1919), Parigi (1920), infine dal 1932 al
Collegio di Francia. L’indagine storica del Gilson ha avuto come nucleo
problematico centrale la ricerca degli antecedenti medievali della filosofia
cartesiana e come risultato quasi costante la rivalutazione del pensiero scolastico,
del quale ha messo ih luce la modernità spesso sorprendente e (come nel saggio su
Abelardo ed Eloisa, 1938) la ricchezza degli interessi e dei valori umani. Gilson è
senza dubbio il più notevole degli studiosi di filosofia medievale della nostra epoca
e in seguito alle sue ricerche il panorama tradizionale della civiltà del medioevo
risulta sensibilmente mutato. Opere principali: Il tomismo (1922), La filosofia di
san Bonaventura (1924), San Tommaso d’Aquino (1925), Introduzione allo studio
di sant’Agostino (1929), Cristianesimo e filosofia (1936), Dante e la filosofia
medievale (1939), La filosofia del medioevo (1944). Dal 1925 ha diretto gli
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age.
GIMNOSOFISTI. Nome dato dagli scrittori della Grecia classica ai membri della setta
ascetica indiana dei digambara, che rappresenta la forma più intransigente del
giainismo. La parola greca (da gymnós, nudo e sophistēs, sapiente) significa «
sapiente nudo », con allusione alla pratica della totale nudità dei digambara. I Greci
conobbero i gimnosofisti in seguito alla spedizione di Alessandro Magno e alle
relazioni degli storici che lo accompagnarono. Onesicrito, in particolare, filosofo
cinico oltre che storico di Alessandro Magno, espose le loro dottrine, mettendone in.
rilievo le affinità con gli ideali etici della scuola cinica.
GIOBÈRTI (Vincenzo), filosofo e uomo politico italiano (Torino 1801 - Parigi 1852).
Ordinato sacerdote ne) 1825, divenne cappellano di corte, ma, sospetto di
appartenere alla « Giovine Italia », fu arrestato il 31 maggio 1833 dal governo
piemontese e poi esiliato. Nel 1846, ormai famoso anche per il successo del Primato
morale e civile degli Italiani* (1843), che aveva segnato il culmine della sua
produzione letteraria e politica, volta a teorizzare il neoguelfismo, cioè una
soluzione federativa, moderata e guelfa del problema italiano, il Gioberti si stabilì a
Parigi, dove rimase fino a quando le vicende politiche gli resero possibile un ritorno
trionfale a Torino (aprile 1848).
Nominato, dopo la sconfitta di Novara, ministro plenipotenziario del re di Sardegna
a Parigi, lasciò presto anche questo incarico ritirandosi in un secondo volontario
esilio e si dedicò alla stesura del Rinnovamento civile d’Italia (1851), che contiene
una revisione in senso unitario e democratico delle sue idee politiche precedenti.
La dottrina del Primato si fonda sostanzialmente su un’interpretazione reazionaria
della storia moderna, desunta in gran parte dalla cultura controrivoluzionaria
francese della Restaurazione, secondo la quale il mondo moderno è nato dalla
Riforma e l’Umanesimo, il soggettivismo filosofico, l’arbitrio morale, l’anarchismo
politico sono conseguenze legittime di quella premessa. La novità personale del