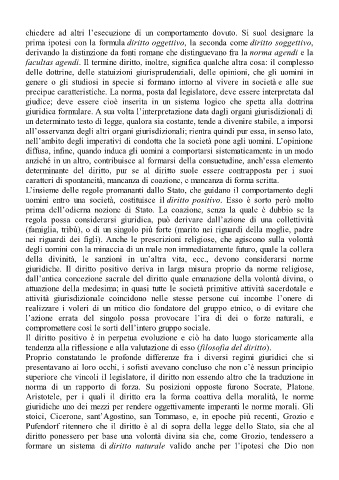Page 256 - Dizionario di Filosofia
P. 256
chiedere ad altri l’esecuzione di un comportamento dovuto. Si suol designare la
prima ipotesi con la formula diritto oggettivo, la seconda come diritto soggettivo,
derivando la distinzione da fonti romane che distinguevano fra la norma agendi e la
facultas agendi. Il termine diritto, inoltre, significa qualche altra cosa: il complesso
delle dottrine, delle statuizioni giurisprudenziali, delle opinioni, che gli uomini in
genere o gli studiosi in specie si formano intorno al vivere in società e alle sue
precipue caratteristiche. La norma, posta dal legislatore, deve essere interpretata dal
giudice; deve essere cioè inserita in un sistema logico che spetta alla dottrina
giuridica formulare. A sua volta l’interpretazione data dagli organi giurisdizionali di
un determinato testo di legge, qualora sia costante, tende a divenire stabile, a imporsi
all’osservanza degli altri organi giurisdizionali; rientra quindi pur essa, in senso lato,
nell’ambito degli imperativi di condotta che la società pone agli uomini. L’opinione
diffusa, infine, quando induca gli uomini a comportarsi sistematicamente in un modo
anziché in un altro, contribuisce al formarsi della consuetudine, anch’essa elemento
determinante del diritto, pur se al diritto suole essere contrapposta per i suoi
caratteri di spontaneità, mancanza di coazione, e mancanza di forma scritta.
L’insieme delle regole promananti dallo Stato, che guidano il comportamento degli
uomini entro una società, costituisce il diritto positivo. Esso è sorto però molto
prima dell’odierna nozione di Stato. La coazione, senza la quale è dubbio se la
regola possa considerarsi giuridica, può derivare dall’azione di una collettività
(famiglia, tribù), o di un singolo più forte (marito nei riguardi della moglie, padre
nei riguardi dei figli). Anche le prescrizioni religiose, che agiscono sulla volontà
degli uomini con la minaccia di un male non immediatamente futuro, quale la collera
della divinità, le sanzioni in un’altra vita, ecc., devono considerarsi norme
giuridiche. Il diritto positivo deriva in larga misura proprio da norme religiose,
dall’antica concezione sacrale del diritto quale emanazione della volontà divina, o
attuazione della medesima; in quasi tutte le società primitive attività sacerdotale e
attività giurisdizionale coincidono nelle stesse persone cui incombe l’onere di
realizzare i voleri di un mitico dio fondatore del gruppo etnico, o di evitare che
l’azione errata del singolo possa provocare l’ira di dei o forze naturali, e
compromettere così le sorti dell’intero gruppo sociale.
Il diritto positivo è in perpetua evoluzione e ciò ha dato luogo storicamente alla
tendenza alla riflessione e alla valutazione di esso (filosofia del diritto).
Proprio constatando le profonde differenze fra i diversi regimi giuridici che si
presentavano ai loro occhi, i sofisti avevano concluso che non c’è nessun principio
superiore che vincoli il legislatore, il diritto non essendo altro che la traduzione in
norma di un rapporto di forza. Su posizioni opposte furono Socrate, Platone,
Aristotele, per i quali il diritto era la forma coattiva della moralità, le norme
giuridiche uno dei mezzi per rendere oggettivamente imperanti le norme morali. Gli
stoici, Cicerone, sant’Agostino, san Tommaso, e, in epoche più recenti, Grozio e
Pufendorf ritennero che il diritto è al di sopra della legge dello Stato, sia che al
diritto ponessero per base una volontà divina sia che, come Grozio, tendessero a
formare un sistema di diritto naturale valido anche per l’ipotesi che Dio non