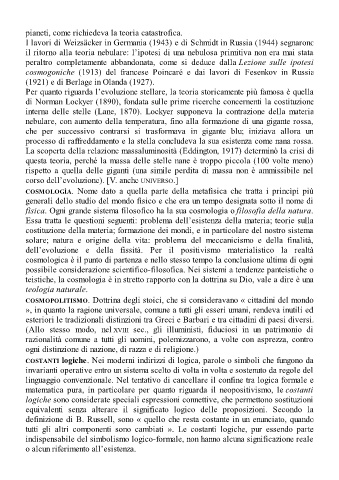Page 216 - Dizionario di Filosofia
P. 216
pianeti, come richiedeva la teoria catastrofica.
I lavori di Weizsäcker in Germania (1943) e di Schmidt in Russia (1944) segnarono
il ritorno alla teoria nebulare: l’ipotesi di una nebulosa primitiva non era mai stata
peraltro completamente abbandonata, come si deduce dalla Lezione sulle ipotesi
cosmogoniche (1913) del francese Poincaré e dai lavori di Fesenkov in Russia
(1921) e di Berlage in Olanda (1927).
Per quanto riguarda l’evoluzione stellare, la teoria storicamente più famosa è quella
di Norman Lockyer (1890), fondata sulle prime ricerche concernenti la costituzione
interna delle stelle (Lane, 1870). Lockyer supponeva la contrazione della materia
nebulare, con aumento della temperatura, fino alla formazione di una gigante rossa,
che per successivo contrarsi si trasformava in gigante blu; iniziava allora un
processo di raffreddamento e la stella concludeva la sua esistenza come nana rossa.
La scoperta della relazione massaluminosità (Eddington, 1917) determinò la crisi di
questa teoria, perché la massa delle stelle nane è troppo piccola (100 volte meno)
rispetto a quella delle giganti (una simile perdita di massa non è ammissibile nel
corso dell’evoluzione). [V. anche UNIVERSO.]
COSMOLOGÌA. Nome dato a quella parte della metafìsica che tratta i princìpi più
generali dello studio del mondo fìsico e che era un tempo designata sotto il nome di
fìsica. Ogni grande sistema filosofico ha la sua cosmologia o filosofia della natura.
Essa tratta le questioni seguenti: problema dell’esistenza della materia; teorie sulla
costituzione della materia; formazione dei mondi, e in particolare del nostro sistema
solare; natura e origine della vita: problema del meccanicismo e della finalità,
dell’evoluzione e della fissità. Per il positivismo materialistico la realtà
cosmologica è il punto di partenza e nello stesso tempo la conclusione ultima di ogni
possibile considerazione scientifico-filosofica. Nei sistemi a tendenze panteistiche o
teistiche, la cosmologia è in stretto rapporto con la dottrina su Dio, vale a dire è una
teologia naturale.
COSMOPOLITISMO. Dottrina degli stoici, che si consideravano « cittadini del mondo
», in quanto la ragione universale, comune a tutti gli esseri umani, rendeva inutili ed
esteriori le tradizionali distinzioni tra Greci e Barbari e tra cittadini di paesi diversi.
(Allo stesso modo, nel XVIII sec., gli illuministi, fiduciosi in un patrimonio di
razionalità comune a tutti gli uomini, polemizzarono, a volte con asprezza, contro
ogni distinzione di nazione, di razza e di religione.)
COSTANTI logiche. Nei moderni indirizzi di logica, parole o simboli che fungono da
invarianti operative entro un sistema scelto di volta in volta e sostenuto da regole del
linguaggio convenzionale. Nel tentativo di cancellare il confine tra logica formale e
matematica pura, in particolare per quanto riguarda il neopositivismo, le costanti
logiche sono considerate speciali espressioni connettive, che permettono sostituzioni
equivalenti senza alterare il significato logico delle proposizioni. Secondo la
definizione di B. Russell, sono « quello che resta costante in un enunciato, quando
tutti gli altri componenti sono cambiati ». Le costanti logiche, pur essendo parte
indispensabile del simbolismo logico-formale, non hanno alcuna significazione reale
o alcun riferimento all’esistenza.