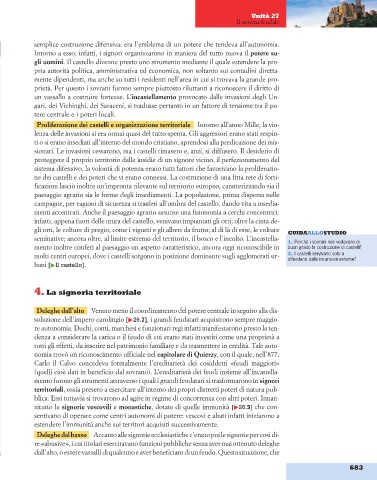Page 698 - Profili di Storia
P. 698
P2_Modulo08.qxp 19-03-2010 13:15 Pagina 683
Unità 27
Il sistema feudale
semplice costruzione difensiva: era l’emblema di un potere che tendeva all’autonomia.
Intorno a esso, infatti, i signori organizzarono in maniera del tutto nuova il potere su-
gli uomini. Il castello divenne presto uno strumento mediante il quale estendere la pro-
pria autorità politica, amministrativa ed economica, non soltanto sui contadini diretta-
mente dipendenti, ma anche su tutti i residenti nell’area in cui si trovava la grande pro-
prietà. Per questo i sovrani furono sempre piuttosto riluttanti a riconoscere il diritto di
un vassallo a costruire fortezze. L’incastellamento provocato dalle invasioni degli Un-
gari, dei Vichinghi, dei Saraceni, si tradusse pertanto in un fattore di tensione tra il po-
tere centrale e i poteri locali.
Proliferazione dei castelli e organizzazione territoriale Intorno all’anno Mille, la vio-
lenza delle invasioni si era ormai quasi del tutto spenta. Gli aggressori erano stati respin-
ti o si erano insediati all’interno del mondo cristiano, aprendosi alla predicazione dei mis-
sionari. Le invasioni cessarono, ma i castelli rimasero e, anzi, si diffusero. Il desiderio di
proteggere il proprio territorio dalle insidie di un signore vicino, il perfezionamento del
sistema difensivo, la volontà di potenza erano tutti fattori che favorivano la proliferazio-
ne dei castelli e dei poteri che vi erano connessi. La costruzione di una fitta rete di forti-
ficazioni lasciò inoltre un’impronta rilevante sul territorio europeo, caratterizzando sia il
paesaggio agrario sia le forme degli insediamenti. La popolazione, prima dispersa nelle
campagne, per ragioni di sicurezza si trasferì all’ombra del castello, dando vita a insedia-
menti accentrati. Anche il paesaggio agrario assunse una fisionomia a cerchi concentrici:
infatti, appena fuori delle mura del castello, venivano impiantati gli orti; oltre la cinta de-
gli orti, le colture di pregio, come i vigneti e gli alberi da frutto; al di là di esse, le colture GUIDAALLOSTUDIO
seminative; ancora oltre, al limite estremo del territorio, il bosco e l’incolto. L’incastella- 1. Perché i sovrani non vedevano di
mento inoltre conferì al paesaggio un aspetto caratteristico, ancora oggi riconoscibile in buon grado la costruzione di castelli?
molti centri europei, dove i castelli sorgono in posizione dominante sugli agglomerati ur- 2. I castelli servivano solo a
difendersi dalle incursioni esterne?
bani [ Il castello].
4. La signoria territoriale
Deleghe dall’alto Venuto meno il coordinamento del potere centrale in seguito alla dis-
soluzione dell’impero carolingio [ 26.7], i grandi feudatari acquisirono sempre maggio-
re autonomia. Duchi, conti, marchesi e funzionari regi infatti manifestarono presto la ten-
denza a considerare la carica o il feudo di cui erano stati investiti come una proprietà a
tutti gli effetti, da inserire nel patrimonio familiare e da trasmettere in eredità. Tale auto-
nomia trovò un riconoscimento ufficiale nel capitolare di Quierzy, con il quale, nell’877,
Carlo il Calvo concedeva formalmente l’ereditarietà dei cosiddetti «feudi maggiori»
(quelli cioè dati in beneficio dal sovrano). L’ereditarietà dei feudi insieme all’incastella-
mento furono gli strumenti attraverso i quali i grandi feudatari si trasformarono in signori
territoriali, ossia presero a esercitare all’interno dei propri distretti poteri di natura pub-
blica. Essi tuttavia si trovarono ad agire in regime di concorrenza con altri poteri. Innan-
zitutto le signorie vescovili e monastiche, dotate di quelle immunità [ 26.5] che con-
sentivano di operare come centri autonomi di potere: vescovi e abati infatti iniziarono a
estendere l’immunità anche sui territori acquisiti successivamente.
Deleghe dal basso Accanto alle signorie ecclesiastiche c’erano poi le signorie per così di-
re «abusive», i cui titolari esercitavano funzioni pubbliche senza aver mai ottenuto deleghe
dall’alto, o essere vassalli di qualcuno e aver beneficiato di un feudo. Questa situazione, che
683