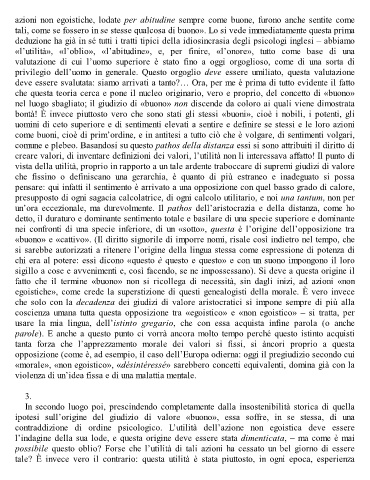Page 31 - Nietzsche - Genealogia della morale
P. 31
azioni non egoistiche, lodate per abitudine sempre come buone, furono anche sentite come
tali, come se fossero in se stesse qualcosa di buono». Lo si vede immediatamente questa prima
deduzione ha già in sé tutti i tratti tipici della idiosincrasia degli psicologi inglesi – abbiamo
«l’utilità», «l’oblio», «l’abitudine», e, per finire, «l’onore», tutto come base di una
valutazione di cui l’uomo superiore è stato fino a oggi orgoglioso, come di una sorta di
privilegio dell’uomo in generale. Questo orgoglio deve essere umiliato, questa valutazione
deve essere svalutata: siamo arrivati a tanto?… Ora, per me è prima di tutto evidente il fatto
che questa teoria cerca e pone il nucleo originario, vero e proprio, del concetto di «buono»
nel luogo sbagliato; il giudizio di «buono» non discende da coloro ai quali viene dimostrata
bontà! È invece piuttosto vero che sono stati gli stessi «buoni», cioè i nobili, i potenti, gli
uomini di ceto superiore e di sentimenti elevati a sentire e definire se stessi e le loro azioni
come buoni, cioè di prim’ordine, e in antitesi a tutto ciò che è volgare, di sentimenti volgari,
comune e plebeo. Basandosi su questo pathos della distanza essi si sono attribuiti il diritto di
creare valori, di inventare definizioni dei valori, l’utilità non li interessava affatto! Il punto di
vista della utilità, proprio in rapporto a un tale ardente traboccare di supremi giudizi di valore
che fissino o definiscano una gerarchia, è quanto di più estraneo e inadeguato si possa
pensare: qui infatti il sentimento è arrivato a una opposizione con quel basso grado di calore,
presupposto di ogni sagacia calcolatrice, di ogni calcolo utilitario, e noi una tantum, non per
un’ora eccezionale, ma durevolmente. Il pathos dell’aristocrazia e della distanza, come ho
detto, il duraturo e dominante sentimento totale e basilare di una specie superiore e dominante
nei confronti di una specie inferiore, di un «sotto», questa è l’origine dell’opposizione tra
«buono» e «cattivo». (Il diritto signorile di imporre nomi, risale così indietro nel tempo, che
si sarebbe autorizzati a ritenere l’origine della lingua stessa come espressione di potenza di
chi era al potere: essi dicono «questo è questo e questo» e con un suono impongono il loro
sigillo a cose e avvenimenti e, così facendo, se ne impossessano). Si deve a questa origine il
fatto che il termine «buono» non si ricollega di necessità, sin dagli inizi, ad azioni «non
egoistiche», come crede la superstizione di questi genealogisti della morale. È vero invece
che solo con la decadenza dei giudizi di valore aristocratici si impone sempre di più alla
coscienza umana tutta questa opposizione tra «egoistico» e «non egoistico» – si tratta, per
usare la mia lingua, dell’istinto gregario, che con essa acquista infine parola (o anche
parole). E anche a questo punto ci vorrà ancora molto tempo perché questo istinto acquisti
tanta forza che l’apprezzamento morale dei valori si fissi, si àncori proprio a questa
opposizione (come è, ad esempio, il caso dell’Europa odierna: oggi il pregiudizio secondo cui
«morale», «non egoistico», «désintéressé» sarebbero concetti equivalenti, domina già con la
violenza di un’idea fissa e di una malattia mentale.
3.
In secondo luogo poi, prescindendo completamente dalla insostenibilità storica di quella
ipotesi sull’origine del giudizio di valore «buono», essa soffre, in se stessa, di una
contraddizione di ordine psicologico. L’utilità dell’azione non egoistica deve essere
l’indagine della sua lode, e questa origine deve essere stata dimenticata, – ma come è mai
possibile questo oblio? Forse che l’utilità di tali azioni ha cessato un bel giorno di essere
tale? È invece vero il contrario: questa utilità è stata piuttosto, in ogni epoca, esperienza