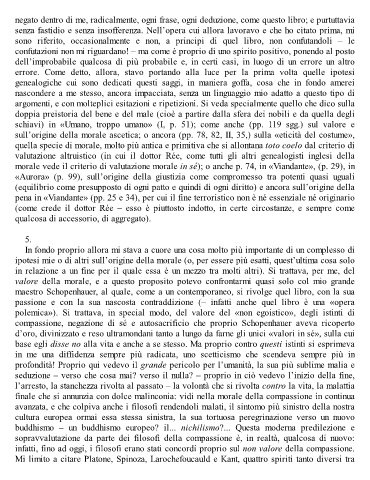Page 27 - Nietzsche - Genealogia della morale
P. 27
negato dentro di me, radicalmente, ogni frase, ogni deduzione, come questo libro; e purtuttavia
senza fastidio e senza insofferenza. Nell’opera cui allora lavoravo e che ho citato prima, mi
sono riferito, occasionalmente e non, a principi di quel libro, non confutandoli – le
confutazioni non mi riguardano! – ma come è proprio di uno spirito positivo, ponendo al posto
dell’improbabile qualcosa di più probabile e, in certi casi, in luogo di un errore un altro
errore. Come detto, allora, stavo portando alla luce per la prima volta quelle ipotesi
genealogiche cui sono dedicati questi saggi, in maniera goffa, cosa che in fondo amerei
nascondere a me stesso, ancora impacciata, senza un linguaggio mio adatto a questo tipo di
argomenti, e con molteplici esitazioni e ripetizioni. Si veda specialmente quello che dico sulla
doppia preistoria del bene e del male (cioè a partire dalla sfera dei nobili e da quella degli
schiavi) in «Umano, troppo umano» (I, p. 51); come anche (pp. 119 sgg.) sul valore e
sull’origine della morale ascetica; o ancora (pp. 78, 82, II, 35,) sulla «eticità del costume»,
quella specie di morale, molto più antica e primitiva che si allontana toto coelo dal criterio di
valutazione altruistico (in cui il dottor Rée, come tutti gli altri genealogisti inglesi della
morale vede il criterio di valutazione morale in sé); o anche p. 74, in «Viandante», (p. 29), in
«Aurora» (p. 99), sull’origine della giustizia come compromesso tra potenti quasi uguali
(equilibrio come presupposto di ogni patto e quindi di ogni diritto) e ancora sull’origine della
pena in «Viandante» (pp. 25 e 34), per cui il fine terroristico non è né essenziale né originario
(come crede il dottor Rée – esso è piuttosto indotto, in certe circostanze, e sempre come
qualcosa di accessorio, di aggregato).
5.
In fondo proprio allora mi stava a cuore una cosa molto più importante di un complesso di
ipotesi mie o di altri sull’origine della morale (o, per essere più esatti, quest’ultima cosa solo
in relazione a un fine per il quale essa è un mezzo tra molti altri). Si trattava, per me, del
valore della morale, e a questo proposito potevo confrontarmi quasi solo col mio grande
maestro Schopenhauer, al quale, come a un contemporaneo, si rivolge quel libro, con la sua
passione e con la sua nascosta contraddizione (– infatti anche quel libro è una «opera
polemica»). Si trattava, in special modo, del valore del «non egoistico», degli istinti di
compassione, negazione di sé e autosacrificio che proprio Schopenhauer aveva ricoperto
d’oro, divinizzato e reso ultramondani tanto a lungo da farne gli unici «valori in sé», sulla cui
base egli disse no alla vita e anche a se stesso. Ma proprio contro questi istinti si esprimeva
in me una diffidenza sempre più radicata, uno scetticismo che scendeva sempre più in
profondità! Proprio qui vedevo il grande pericolo per l’umanità, la sua più sublime malia e
seduzione – verso che cosa mai? verso il nulla? – proprio in ciò vedevo l’inizio della fine,
l’arresto, la stanchezza rivolta al passato – la volontà che si rivolta contro la vita, la malattia
finale che si annunzia con dolce malinconia: vidi nella morale della compassione in continua
avanzata, e che colpiva anche i filosofi rendendoli malati, il sintomo più sinistro della nostra
cultura europea ormai essa stessa sinistra, la sua tortuosa peregrinazione verso un nuovo
buddhismo – un buddhismo europeo? il... nichilismo?... Questa moderna predilezione e
sopravvalutazione da parte dei filosofi della compassione è, in realtà, qualcosa di nuovo:
infatti, fino ad oggi, i filosofi erano stati concordi proprio sul non valore della compassione.
Mi limito a citare Platone, Spinoza, Larochefoucauld e Kant, quattro spiriti tanto diversi tra