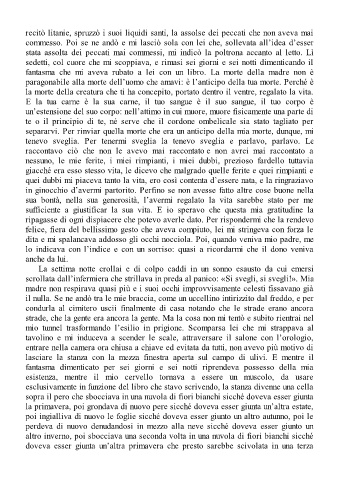Page 89 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 89
recitò litanie, spruzzò i suoi liquidi santi, la assolse dei peccati che non aveva mai
commesso. Poi se ne andò e mi lasciò sola con lei che, sollevata all’idea d’esser
stata assolta dei peccati mai commessi, mi indicò la poltrona accanto al letto. Lì
sedetti, col cuore che mi scoppiava, e rimasi sei giorni e sei notti dimenticando il
fantasma che mi aveva rubato a lei con un libro. La morte della madre non è
paragonabile alla morte dell’uomo che amavi: è l’anticipo della tua morte. Perché è
la morte della creatura che ti ha concepito, portato dentro il ventre, regalato la vita.
E la tua carne è la sua carne, il tuo sangue è il suo sangue, il tuo corpo è
un’estensione del suo corpo: nell’attimo in cui muore, muore fisicamente una parte di
te o il principio di te, né serve che il cordone ombelicale sia stato tagliato per
separarvi. Per rinviar quella morte che era un anticipo della mia morte, dunque, mi
tenevo sveglia. Per tenermi sveglia la tenevo sveglia e parlavo, parlavo. Le
raccontavo ciò che non le avevo mai raccontato e non avrei mai raccontato a
nessuno, le mie ferite, i miei rimpianti, i miei dubbi, prezioso fardello tuttavia
giacché era esso stesso vita, le dicevo che malgrado quelle ferite e quei rimpianti e
quei dubbi mi piaceva tanto la vita, ero così contenta d’essere nata, e la ringraziavo
in ginocchio d’avermi partorito. Perfino se non avesse fatto altre cose buone nella
sua bontà, nella sua generosità, l’avermi regalato la vita sarebbe stato per me
sufficiente a giustificar la sua vita. E io speravo che questa mia gratitudine la
ripagasse di ogni dispiacere che potevo averle dato. Per rispondermi che la rendevo
felice, fiera del bellissimo gesto che aveva compiuto, lei mi stringeva con forza le
dita e mi spalancava addosso gli occhi nocciola. Poi, quando veniva mio padre, me
lo indicava con l’indice e con un sorriso: quasi a ricordarmi che il dono veniva
anche da lui.
La settima notte crollai e di colpo caddi in un sonno esausto da cui emersi
scrollata dall’infermiera che strillava in preda al panico: «Si svegli, si svegli!». Mia
madre non respirava quasi più e i suoi occhi improvvisamente celesti fissavano già
il nulla. Se ne andò tra le mie braccia, come un uccellino intirizzito dal freddo, e per
condurla al cimitero uscii finalmente di casa notando che le strade erano ancora
strade, che la gente era ancora la gente. Ma la cosa non mi tentò e subito rientrai nel
mio tunnel trasformando l’esilio in prigione. Scomparsa lei che mi strappava al
tavolino e mi induceva a scender le scale, attraversare il salone con l’orologio,
entrare nella camera ora chiusa a chiave ed evitata da tutti, non avevo più motivo di
lasciare la stanza con la mezza finestra aperta sul campo di ulivi. E mentre il
fantasma dimenticato per sei giorni e sei notti riprendeva possesso della mia
esistenza, mentre il mio cervello tornava a essere un muscolo, da usare
esclusivamente in funzione del libro che stavo scrivendo, la stanza divenne una cella
sopra il pero che sbocciava in una nuvola di fiori bianchi sicché doveva esser giunta
la primavera, poi grondava di nuovo pere sicché doveva esser giunta un’altra estate,
poi ingialliva di nuovo le foglie sicché doveva esser giunto un altro autunno, poi le
perdeva di nuovo denudandosi in mezzo alla neve sicché doveva esser giunto un
altro inverno, poi sbocciava una seconda volta in una nuvola di fiori bianchi sicché
doveva esser giunta un’altra primavera che presto sarebbe scivolata in una terza