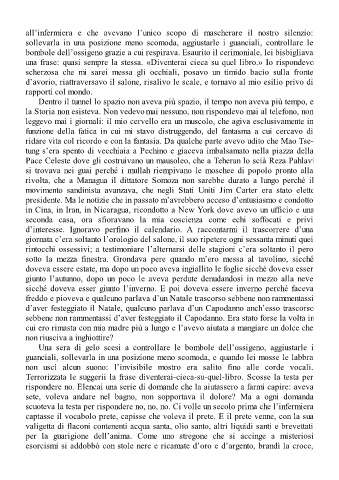Page 88 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 88
all’infermiera e che avevano l’unico scopo di mascherare il nostro silenzio:
sollevarla in una posizione meno scomoda, aggiustarle i guanciali, controllare le
bombole dell’ossigeno grazie a cui respirava. Esaurito il cerimoniale, lei bisbigliava
una frase: quasi sempre la stessa. «Diventerai cieca su quel libro.» Io rispondevo
scherzosa che mi sarei messa gli occhiali, posavo un timido bacio sulla fronte
d’avorio, riattraversavo il salone, risalivo le scale, e tornavo al mio esilio privo di
rapporti col mondo.
Dentro il tunnel lo spazio non aveva più spazio, il tempo non aveva più tempo, e
la Storia non esisteva. Non vedevo mai nessuno, non rispondevo mai al telefono, non
leggevo mai i giornali: il mio cervello era un muscolo, che agiva esclusivamente in
funzione della fatica in cui mi stavo distruggendo, del fantasma a cui cercavo di
ridare vita col ricordo e con la fantasia. Da qualche parte avevo udito che Mao Tse-
tung s’era spento di vecchiaia a Pechino e giaceva imbalsamato nella piazza della
Pace Celeste dove gli costruivano un mausoleo, che a Teheran lo scià Reza Pahlavi
si trovava nei guai perché i mullah riempivano le moschee di popolo pronto alla
rivolta, che a Managua il dittatore Somoza non sarebbe durato a lungo perché il
movimento sandinista avanzava, che negli Stati Uniti Jim Carter era stato eletto
presidente. Ma le notizie che in passato m’avrebbero acceso d’entusiasmo e condotto
in Cina, in Iran, in Nicaragua, ricondotto a New York dove avevo un ufficio e una
seconda casa, ora sfioravano la mia coscienza come echi soffocati e privi
d’interesse. Ignoravo perfino il calendario. A raccontarmi il trascorrere d’una
giornata c’era soltanto l’orologio del salone, il suo ripetere ogni sessanta minuti quei
rintocchi ossessivi; a testimoniare l’alternarsi delle stagioni c’era soltanto il pero
sotto la mezza finestra. Grondava pere quando m’ero messa al tavolino, sicché
doveva essere estate, ma dopo un poco aveva ingiallito le foglie sicché doveva esser
giunto l’autunno, dopo un poco le aveva perdute denudandosi in mezzo alla neve
sicché doveva esser giunto l’inverno. E poi doveva essere inverno perché faceva
freddo e pioveva e qualcuno parlava d’un Natale trascorso sebbene non rammentassi
d’aver festeggiato il Natale, qualcuno parlava d’un Capodanno anch’esso trascorso
sebbene non rammentassi d’aver festeggiato il Capodanno. Era stato forse la volta in
cui ero rimasta con mia madre più a lungo e l’avevo aiutata a mangiare un dolce che
non riusciva a inghiottire?
Una sera di gelo scesi a controllare le bombole dell’ossigeno, aggiustarle i
guanciali, sollevarla in una posizione meno scomoda, e quando lei mosse le labbra
non uscì alcun suono: l’invisibile mostro era salito fino alle corde vocali.
Terrorizzata le suggerii la frase diventerai-cieca-su-quel-libro. Scosse la testa per
rispondere no. Elencai una serie di domande che la aiutassero a farmi capire: aveva
sete, voleva andare nel bagno, non sopportava il dolore? Ma a ogni domanda
scuoteva la testa per rispondere no, no, no. Ci volle un secolo prima che l’infermiera
captasse il vocabolo prete, capisse che voleva il prete. E il prete venne, con la sua
valigetta di flaconi contenenti acqua santa, olio santo, altri liquidi santi e brevettati
per la guarigione dell’anima. Come uno stregone che si accinge a misteriosi
esorcismi si addobbò con stole nere e ricamate d’oro e d’argento, brandì la croce,