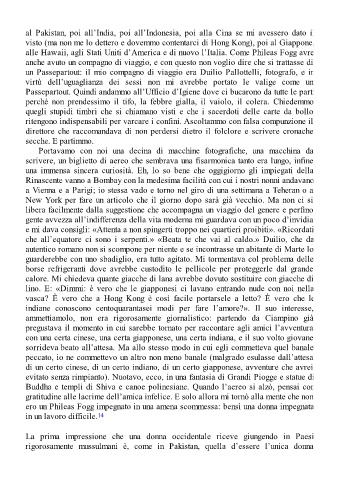Page 48 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 48
al Pakistan, poi all’India, poi all’Indonesia, poi alla Cina se mi avessero dato il
visto (ma non me lo dettero e dovemmo contentarci di Hong Kong), poi al Giappone,
alle Hawaii, agli Stati Uniti d’America e di nuovo l’Italia. Come Phileas Fogg avrei
anche avuto un compagno di viaggio, e con questo non voglio dire che si trattasse di
un Passepartout: il mio compagno di viaggio era Duilio Pallottelli, fotografo, e in
virtù dell’uguaglianza dei sessi non mi avrebbe portato le valige come un
Passepartout. Quindi andammo all’Ufficio d’Igiene dove ci bucarono da tutte le parti
perché non prendessimo il tifo, la febbre gialla, il vaiolo, il colera. Chiedemmo
quegli stupidi timbri che si chiamano visti e che i sacerdoti delle carte da bollo
ritengono indispensabili per varcare i confini. Ascoltammo con falsa compunzione il
direttore che raccomandava di non perdersi dietro il folclore e scrivere cronache
secche. E partimmo.
Portavamo con noi una decina di macchine fotografiche, una macchina da
scrivere, un biglietto di aereo che sembrava una fisarmonica tanto era lungo, infine
una immensa sincera curiosità. Eh, lo so bene che oggigiorno gli impiegati della
Rinascente vanno a Bombay con la medesima facilità con cui i nostri nonni andavano
a Vienna e a Parigi; io stessa vado e torno nel giro di una settimana a Teheran o a
New York per fare un articolo che il giorno dopo sarà già vecchio. Ma non ci si
libera facilmente dalla suggestione che accompagna un viaggio del genere e perfino
gente avvezza all’indifferenza della vita moderna mi guardava con un poco d’invidia
e mi dava consigli: «Attenta a non spingerti troppo nei quartieri proibiti». «Ricordati
che all’equatore ci sono i serpenti.» «Beata te che vai al caldo.» Duilio, che da
autentico romano non si scompone per niente e se incontrasse un abitante di Marte lo
guarderebbe con uno sbadiglio, era tutto agitato. Mi tormentava col problema delle
borse refrigeranti dove avrebbe custodito le pellicole per proteggerle dal grande
calore. Mi chiedeva quante giacche di lana avrebbe dovuto sostituire con giacche di
lino. E: «Dimmi: è vero che le giapponesi ci lavano entrando nude con noi nella
vasca? È vero che a Hong Kong è così facile portarsele a letto? È vero che le
indiane conoscono centoquarantasei modi per fare l’amore?». Il suo interesse,
ammettiamolo, non era rigorosamente giornalistico: partendo da Ciampino già
pregustava il momento in cui sarebbe tornato per raccontare agli amici l’avventura
con una certa cinese, una certa giapponese, una certa indiana, e il suo volto giovane
sorrideva beato all’attesa. Ma allo stesso modo in cui egli commetteva quel banale
peccato, io ne commettevo un altro non meno banale (malgrado esulasse dall’attesa
di un certo cinese, di un certo indiano, di un certo giapponese, avventure che avrei
evitato senza rimpianto). Nuotavo, ecco, in una fantasia di Grandi Piogge e statue di
Buddha e templi di Shiva e canoe polinesiane. Quando l’aereo si alzò, pensai con
gratitudine alle lacrime dell’amica infelice. E solo allora mi tornò alla mente che non
ero un Phileas Fogg impegnato in una amena scommessa: bensì una donna impegnata
in un lavoro difficile. 14
La prima impressione che una donna occidentale riceve giungendo in Paesi
rigorosamente mussulmani è, come in Pakistan, quella d’essere l’unica donna