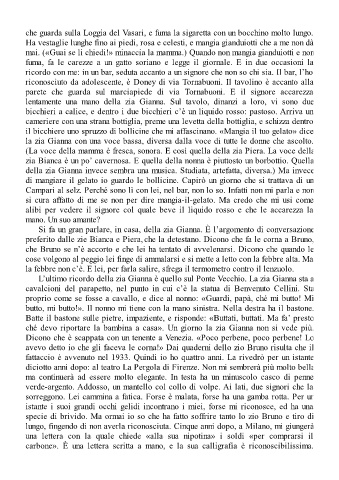Page 13 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 13
che guarda sulla Loggia del Vasari, e fuma la sigaretta con un bocchino molto lungo.
Ha vestaglie lunghe fino ai piedi, rosa e celesti, e mangia gianduiotti che a me non dà
mai. («Guai se li chiedi!» minaccia la mamma.) Quando non mangia gianduiotti e non
fuma, fa le carezze a un gatto soriano e legge il giornale. E in due occasioni la
ricordo con me: in un bar, seduta accanto a un signore che non so chi sia. Il bar, l’ho
riconosciuto da adolescente, è Doney di via Tornabuoni. Il tavolino è accanto alla
parete che guarda sul marciapiede di via Tornabuoni. E il signore accarezza
lentamente una mano della zia Gianna. Sul tavolo, dinanzi a loro, vi sono due
bicchieri a calice, e dentro i due bicchieri c’è un liquido rosso: pastoso. Arriva un
cameriere con una strana bottiglia, preme una levetta della bottiglia, e schizza dentro
il bicchiere uno spruzzo di bollicine che mi affascinano. «Mangia il tuo gelato» dice
la zia Gianna con una voce bassa, diversa dalla voce di tutte le donne che ascolto.
(La voce della mamma è fresca, sonora. E così quella della zia Piera. La voce della
zia Bianca è un po’ cavernosa. E quella della nonna è piuttosto un borbottio. Quella
della zia Gianna invece sembra una musica. Studiata, artefatta, diversa.) Ma invece
di mangiare il gelato io guardo le bollicine. Capirò un giorno che si trattava di un
Campari al selz. Perché sono lì con lei, nel bar, non lo so. Infatti non mi parla e non
si cura affatto di me se non per dire mangia-il-gelato. Ma credo che mi usi come
alibi per vedere il signore col quale beve il liquido rosso e che le accarezza la
mano. Un suo amante?
Si fa un gran parlare, in casa, della zia Gianna. È l’argomento di conversazione
preferito dalle zie Bianca e Piera, che la detestano. Dicono che fa le corna a Bruno,
che Bruno se n’è accorto e che lei ha tentato di avvelenarsi. Dicono che quando le
cose volgono al peggio lei finge di ammalarsi e si mette a letto con la febbre alta. Ma
la febbre non c’è. E lei, per farla salire, sfrega il termometro contro il lenzuolo.
L’ultimo ricordo della zia Gianna è quello sul Ponte Vecchio. La zia Gianna sta a
cavalcioni del parapetto, nel punto in cui c’è la statua di Benvenuto Cellini. Sta
proprio come se fosse a cavallo, e dice al nonno: «Guardi, papà, ché mi butto! Mi
butto, mi butto!». Il nonno mi tiene con la mano sinistra. Nella destra ha il bastone.
Batte il bastone sulle pietre, impaziente, e risponde: «Buttati, buttati. Ma fa’ presto
ché devo riportare la bambina a casa». Un giorno la zia Gianna non si vede più.
Dicono che è scappata con un tenente a Venezia. «Poco perbene, poco perbene! Lo
avevo detto io che gli faceva le corna!» Dai quaderni dello zio Bruno risulta che il
fattaccio è avvenuto nel 1933. Quindi io ho quattro anni. La rivedrò per un istante
diciotto anni dopo: al teatro La Pergola di Firenze. Non mi sembrerà più molto bella
ma continuerà ad essere molto elegante. In testa ha un minuscolo casco di penne
verde-argento. Addosso, un mantello col collo di volpe. Ai lati, due signori che la
sorreggono. Lei cammina a fatica. Forse è malata, forse ha una gamba rotta. Per un
istante i suoi grandi occhi gelidi incontrano i miei, forse mi riconosce, ed ha una
specie di brivido. Ma ormai io so che ha fatto soffrire tanto lo zio Bruno e tiro di
lungo, fingendo di non averla riconosciuta. Cinque anni dopo, a Milano, mi giungerà
una lettera con la quale chiede «alla sua nipotina» i soldi «per comprarsi il
carbone». È una lettera scritta a mano, e la sua calligrafia è riconoscibilissima.