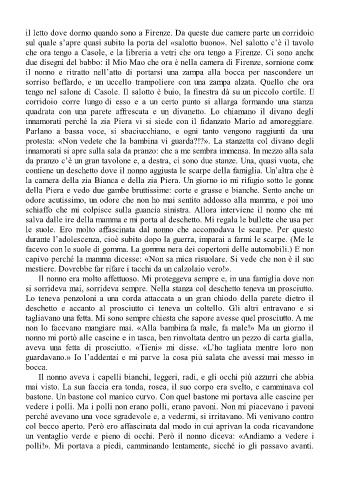Page 10 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 10
il letto dove dormo quando sono a Firenze. Da queste due camere parte un corridoio
sul quale s’apre quasi subito la porta del «salotto buono». Nel salotto c’è il tavolo
che ora tengo a Casole, e la libreria a vetri che ora tengo a Firenze. Ci sono anche
due disegni del babbo: il Mio Mao che ora è nella camera di Firenze, sornione come
il nonno e ritratto nell’atto di portarsi una zampa alla bocca per nascondere un
sorriso beffardo, e un uccello trampoliere con una zampa alzata. Quello che ora
tengo nel salone di Casole. Il salotto è buio, la finestra dà su un piccolo cortile. Il
corridoio corre lungo di esso e a un certo punto si allarga formando una stanza
quadrata con una parete affrescata e un divanetto. Lo chiamano il divano degli
innamorati perché la zia Piera vi si siede con il fidanzato Mario ad amoreggiare.
Parlano a bassa voce, si sbaciucchiano, e ogni tanto vengono raggiunti da una
protesta: «Non vedete che la bambina vi guarda?!?». La stanzetta col divano degli
innamorati si apre sulla sala da pranzo: che a me sembra immensa. In mezzo alla sala
da pranzo c’è un gran tavolone e, a destra, ci sono due stanze. Una, quasi vuota, che
contiene un deschetto dove il nonno aggiusta le scarpe della famiglia. Un’altra che è
la camera della zia Bianca e della zia Piera. Un giorno io mi rifugio sotto le gonne
della Piera e vedo due gambe bruttissime: corte e grasse e bianche. Sento anche un
odore acutissimo, un odore che non ho mai sentito addosso alla mamma, e poi uno
schiaffo che mi colpisce sulla guancia sinistra. Allora interviene il nonno che mi
salva dalle ire della mamma e mi porta al deschetto. Mi regala le bullette che usa per
le suole. Ero molto affascinata dal nonno che accomodava le scarpe. Per questo
durante l’adolescenza, cioè subito dopo la guerra, imparai a farmi le scarpe. (Me le
facevo con le suole di gomma. La gomma nera dei copertoni delle automobili.) E non
capivo perché la mamma dicesse: «Non sa mica risuolare. Si vede che non è il suo
mestiere. Dovrebbe far rifare i tacchi da un calzolaio vero!».
Il nonno era molto affettuoso. Mi proteggeva sempre e, in una famiglia dove non
si sorrideva mai, sorrideva sempre. Nella stanza col deschetto teneva un prosciutto.
Lo teneva penzoloni a una corda attaccata a un gran chiodo della parete dietro il
deschetto e accanto al prosciutto ci teneva un coltello. Gli altri entravano e si
tagliavano una fetta. Mi sono sempre chiesta che sapore avesse quel prosciutto. A me
non lo facevano mangiare mai. «Alla bambina fa male, fa male!» Ma un giorno il
nonno mi portò alle cascine e in tasca, ben rinvoltata dentro un pezzo di carta gialla,
aveva una fetta di prosciutto. «Tieni» mi disse. «L’ho tagliata mentre loro non
guardavano.» Io l’addentai e mi parve la cosa più salata che avessi mai messo in
bocca.
Il nonno aveva i capelli bianchi, leggeri, radi, e gli occhi più azzurri che abbia
mai visto. La sua faccia era tonda, rosea, il suo corpo era svelto, e camminava col
bastone. Un bastone col manico curvo. Con quel bastone mi portava alle cascine per
vedere i polli. Ma i polli non erano polli, erano pavoni. Non mi piacevano i pavoni
perché avevano una voce sgradevole e, a vedermi, si irritavano. Mi venivano contro
col becco aperto. Però ero affascinata dal modo in cui aprivan la coda ricavandone
un ventaglio verde e pieno di occhi. Però il nonno diceva: «Andiamo a vedere i
polli!». Mi portava a piedi, camminando lentamente, sicché io gli passavo avanti.