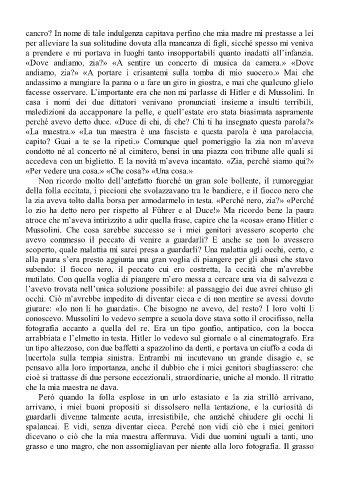Page 18 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 18
cancro? In nome di tale indulgenza capitava perfino che mia madre mi prestasse a lei
per alleviare la sua solitudine dovuta alla mancanza di figli, sicché spesso mi veniva
a prendere e mi portava in luoghi tanto insopportabili quanto inadatti all’infanzia.
«Dove andiamo, zia?» «A sentire un concerto di musica da camera.» «Dove
andiamo, zia?» «A portare i crisantemi sulla tomba di mio suocero.» Mai che
andassimo a mangiare la panna o a fare un giro in giostra, e mai che qualcuno glielo
facesse osservare. L’importante era che non mi parlasse di Hitler e di Mussolini. In
casa i nomi dei due dittatori venivano pronunciati insieme a insulti terribili,
maledizioni da accapponare la pelle, e quell’estate ero stata biasimata aspramente
perché avevo detto duce. «Duce di chi, di che? Chi ti ha insegnato questa parola?»
«La maestra.» «La tua maestra è una fascista e questa parola è una parolaccia,
capito? Guai a te se la ripeti.» Comunque quel pomeriggio la zia non m’aveva
condotto né al concerto né al cimitero, bensì in una piazza con tribune alle quali si
accedeva con un biglietto. E la novità m’aveva incantato. «Zia, perché siamo qui?»
«Per vedere una cosa.» «Che cosa?» «Una cosa.»
Non ricordo molto dell’antefatto fuorché un gran sole bollente, il rumoreggiar
della folla eccitata, i piccioni che svolazzavano tra le bandiere, e il fiocco nero che
la zia aveva tolto dalla borsa per annodarmelo in testa. «Perché nero, zia?» «Perché
lo zio ha detto nero per rispetto al Führer e al Duce!» Ma ricordo bene la paura
atroce che m’aveva intirizzito a udir quella frase, capire che la «cosa» erano Hitler e
Mussolini. Che cosa sarebbe successo se i miei genitori avessero scoperto che
avevo commesso il peccato di venire a guardarli? E anche se non lo avessero
scoperto, quale malattia mi sarei presa a guardarli? Una malattia agli occhi, certo, e
alla paura s’era presto aggiunta una gran voglia di piangere per gli abusi che stavo
subendo: il fiocco nero, il peccato cui ero costretta, la cecità che m’avrebbe
mutilato. Con quella voglia di piangere m’ero messa a cercare una via di salvezza e
l’avevo trovata nell’unica soluzione possibile: al passaggio dei due avrei chiuso gli
occhi. Ciò m’avrebbe impedito di diventar cieca e di non mentire se avessi dovuto
giurare: «Io non li ho guardati». Che bisogno ne avevo, del resto? I loro volti li
conoscevo. Mussolini lo vedevo sempre a scuola dove stava sotto il crocifisso, nella
fotografia accanto a quella del re. Era un tipo gonfio, antipatico, con la bocca
arrabbiata e l’elmetto in testa. Hitler lo vedevo sul giornale o al cinematografo. Era
un tipo altezzoso, con due baffetti a spazzolino da denti, e portava un ciuffo a coda di
lucertola sulla tempia sinistra. Entrambi mi incutevano un grande disagio e, se
pensavo alla loro importanza, anche il dubbio che i miei genitori sbagliassero: che
cioè si trattasse di due persone eccezionali, straordinarie, uniche al mondo. Il ritratto
che la mia maestra ne dava.
Però quando la folla esplose in un urlo estasiato e la zia strillò arrivano,
arrivano, i miei buoni propositi si dissolsero nella tentazione, e la curiosità di
guardarli divenne talmente acuta, irresistibile, che anziché chiudere gli occhi li
spalancai. E vidi, senza diventar cieca. Perché non vidi ciò che i miei genitori
dicevano o ciò che la mia maestra affermava. Vidi due uomini uguali a tanti, uno
grasso e uno magro, che non assomigliavan per niente alla loro fotografia. Il grasso