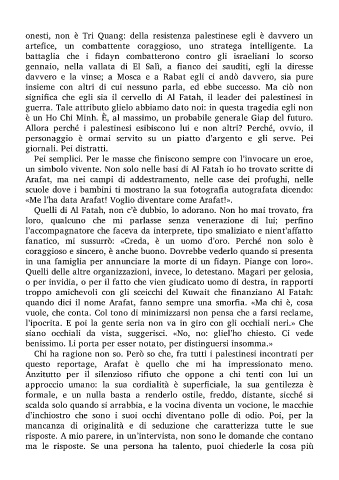Page 84 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 84
onesti, non è Tri Quang: della resistenza palestinese egli è davvero un
arte ce, un combattente coraggioso, uno stratega intelligente. La
battaglia che i dayn combatterono contro gli israeliani lo scorso
gennaio, nella vallata di El Salì, a anco dei sauditi, egli la diresse
davvero e la vinse; a Mosca e a Rabat egli ci andò davvero, sia pure
insieme con altri di cui nessuno parla, ed ebbe successo. Ma ciò non
signi ca che egli sia il cervello di Al Fatah, il leader dei palestinesi in
guerra. Tale attributo glielo abbiamo dato noi: in questa tragedia egli non
è un Ho Chi Minh. È, al massimo, un probabile generale Giap del futuro.
Allora perché i palestinesi esibiscono lui e non altri? Perché, ovvio, il
personaggio è ormai servito su un piatto d’argento e gli serve. Pei
giornali. Pei distratti.
Pei semplici. Per le masse che niscono sempre con l’invocare un eroe,
un simbolo vivente. Non solo nelle basi di Al Fatah io ho trovato scritte di
Arafat, ma nei campi di addestramento, nelle case dei profughi, nelle
scuole dove i bambini ti mostrano la sua fotogra a autografata dicendo:
«Me l’ha data Arafat! Voglio diventare come Arafat!».
Quelli di Al Fatah, non c’è dubbio, lo adorano. Non ho mai trovato, fra
loro, qualcuno che mi parlasse senza venerazione di lui; per no
l’accompagnatore che faceva da interprete, tipo smaliziato e nient’a atto
fanatico, mi sussurrò: «Creda, è un uomo d’oro. Perché non solo è
coraggioso e sincero, è anche buono. Dovrebbe vederlo quando si presenta
in una famiglia per annunciare la morte di un dayn. Piange con loro».
Quelli delle altre organizzazioni, invece, lo detestano. Magari per gelosia,
o per invidia, o per il fatto che vien giudicato uomo di destra, in rapporti
troppo amichevoli con gli sceicchi del Kuwait che nanziano Al Fatah:
quando dici il nome Arafat, fanno sempre una smor a. «Ma chi è, cosa
vuole, che conta. Col tono di minimizzarsi non pensa che a farsi reclame,
l’ipocrita. E poi la gente seria non va in giro con gli occhiali neri.» Che
siano occhiali da vista, suggerisci. «No, no: gliel’ho chiesto. Ci vede
benissimo. Li porta per esser notato, per distinguersi insomma.»
Chi ha ragione non so. Però so che, fra tutti i palestinesi incontrati per
questo reportage, Arafat è quello che mi ha impressionato meno.
Anzitutto per il silenzioso ri uto che oppone a chi tenti con lui un
approccio umano: la sua cordialità è super ciale, la sua gentilezza è
formale, e un nulla basta a renderlo ostile, freddo, distante, sicché si
scalda solo quando si arrabbia, e la vocina diventa un vocione, le macchie
d’inchiostro che sono i suoi occhi diventano polle di odio. Poi, per la
mancanza di originalità e di seduzione che caratterizza tutte le sue
risposte. A mio parere, in un’intervista, non sono le domande che contano
ma le risposte. Se una persona ha talento, puoi chiederle la cosa più