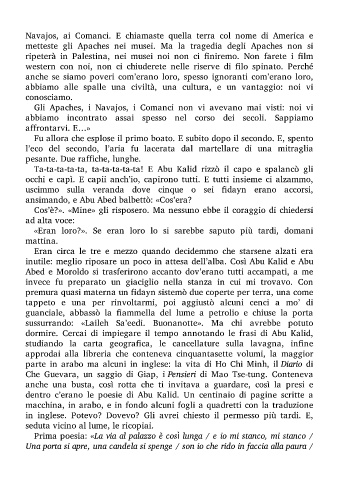Page 71 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 71
Navajos, ai Comanci. E chiamaste quella terra col nome di America e
metteste gli Apaches nei musei. Ma la tragedia degli Apaches non si
ripeterà in Palestina, nei musei noi non ci niremo. Non farete i lm
western con noi, non ci chiuderete nelle riserve di lo spinato. Perché
anche se siamo poveri com’erano loro, spesso ignoranti com’erano loro,
abbiamo alle spalle una civiltà, una cultura, e un vantaggio: noi vi
conosciamo.
Gli Apaches, i Navajos, i Comanci non vi avevano mai visti: noi vi
abbiamo incontrato assai spesso nel corso dei secoli. Sappiamo
affrontarvi. E…»
Fu allora che esplose il primo boato. E subito dopo il secondo. E, spento
l’eco del secondo, l’aria fu lacerata dal martellare di una mitraglia
pesante. Due raffiche, lunghe.
Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta! E Abu Kalid rizzò il capo e spalancò gli
occhi e capì. E capii anch’io, capirono tutti. E tutti insieme ci alzammo,
uscimmo sulla veranda dove cinque o sei dayn erano accorsi,
ansimando, e Abu Abed balbettò: «Cos’era?
Cos’è?». «Mine» gli risposero. Ma nessuno ebbe il coraggio di chiedersi
ad alta voce:
«Eran loro?». Se eran loro lo si sarebbe saputo più tardi, domani
mattina.
Eran circa le tre e mezzo quando decidemmo che starsene alzati era
inutile: meglio riposare un poco in attesa dell’alba. Così Abu Kalid e Abu
Abed e Moroldo si trasferirono accanto dov’erano tutti accampati, a me
invece fu preparato un giaciglio nella stanza in cui mi trovavo. Con
premura quasi materna un fidayn sistemò due coperte per terra, una come
tappeto e una per rinvoltarmi, poi aggiustò alcuni cenci a mo’ di
guanciale, abbassò la ammella del lume a petrolio e chiuse la porta
sussurrando: «Laileh Sa’eedi. Buonanotte». Ma chi avrebbe potuto
dormire. Cercai di impiegare il tempo annotando le frasi di Abu Kalid,
studiando la carta geogra ca, le cancellature sulla lavagna, in ne
approdai alla libreria che conteneva cinquantasette volumi, la maggior
parte in arabo ma alcuni in inglese: la vita di Ho Chi Minh, il Diario di
Che Guevara, un saggio di Giap, i Pensieri di Mao Tse-tung. Conteneva
anche una busta, così rotta che ti invitava a guardare, così la presi e
dentro c’erano le poesie di Abu Kalid. Un centinaio di pagine scritte a
macchina, in arabo, e in fondo alcuni fogli a quadretti con la traduzione
in inglese. Potevo? Dovevo? Gli avrei chiesto il permesso più tardi. E,
seduta vicino al lume, le ricopiai.
Prima poesia: «La via al palazzo è così lunga / e io mi stanco, mi stanco /
Una porta si apre, una candela si spenge / son io che rido in faccia alla paura /