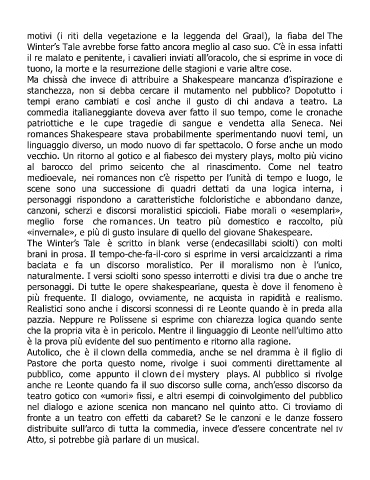Page 599 - Shakespeare - Vol. 4
P. 599
motivi (i riti della vegetazione e la leggenda del Graal), la fiaba del The
Winter’s Tale avrebbe forse fatto ancora meglio al caso suo. C’è in essa infatti
il re malato e penitente, i cavalieri inviati all’oracolo, che si esprime in voce di
tuono, la morte e la resurrezione delle stagioni e varie altre cose.
Ma chissà che invece di attribuire a Shakespeare mancanza d’ispirazione e
stanchezza, non si debba cercare il mutamento nel pubblico? Dopotutto i
tempi erano cambiati e così anche il gusto di chi andava a teatro. La
commedia italianeggiante doveva aver fatto il suo tempo, come le cronache
patriottiche e le cupe tragedie di sangue e vendetta alla Seneca. Nei
romances Shakespeare stava probabilmente sperimentando nuovi temi, un
linguaggio diverso, un modo nuovo di far spettacolo. O forse anche un modo
vecchio. Un ritorno al gotico e al fiabesco dei mystery plays, molto più vicino
al barocco del primo seicento che al rinascimento. Come nel teatro
medioevale, nei romances non c’è rispetto per l’unità di tempo e luogo, le
scene sono una successione di quadri dettati da una logica interna, i
personaggi rispondono a caratteristiche folcloristiche e abbondano danze,
canzoni, scherzi e discorsi moralistici spiccioli. Fiabe morali o «esemplari»,
meglio forse che romances. Un teatro più domestico e raccolto, più
«invernale», e più di gusto insulare di quello del giovane Shakespeare.
The Winter’s Tale è scritto in blank verse (endecasillabi sciolti) con molti
brani in prosa. Il tempo-che-fa-il-coro si esprime in versi arcaicizzanti a rima
baciata e fa un discorso moralistico. Per il moralismo non è l’unico,
naturalmente. I versi sciolti sono spesso interrotti e divisi tra due o anche tre
personaggi. Di tutte le opere shakespeariane, questa è dove il fenomeno è
più frequente. Il dialogo, ovviamente, ne acquista in rapidità e realismo.
Realistici sono anche i discorsi sconnessi di re Leonte quando è in preda alla
pazzia. Neppure re Polissene si esprime con chiarezza logica quando sente
che la propria vita è in pericolo. Mentre il linguaggio di Leonte nell’ultimo atto
è la prova più evidente del suo pentimento e ritorno alla ragione.
Autolico, che è il clown della commedia, anche se nel dramma è il figlio di
Pastore che porta questo nome, rivolge i suoi commenti direttamente al
pubblico, come appunto il clown dei mystery plays. Al pubblico si rivolge
anche re Leonte quando fa il suo discorso sulle corna, anch’esso discorso da
teatro gotico con «umori» fissi, e altri esempi di coinvolgimento del pubblico
nel dialogo e azione scenica non mancano nel quinto atto. Ci troviamo di
fronte a un teatro con effetti da cabaret? Se le canzoni e le danze fossero
distribuite sull’arco di tutta la commedia, invece d’essere concentrate nel IV
Atto, si potrebbe già parlare di un musical.