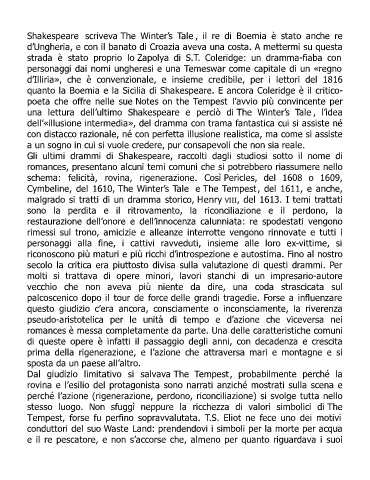Page 598 - Shakespeare - Vol. 4
P. 598
Shakespeare scriveva The Winter’s Tale , il re di Boemia è stato anche re
d’Ungheria, e con il banato di Croazia aveva una costa. A mettermi su questa
strada è stato proprio lo Zapolya di S.T. Coleridge: un dramma-fiaba con
personaggi dai nomi ungheresi e una Temeswar come capitale di un «regno
d’Illiria», che è convenzionale, e insieme credibile, per i lettori del 1816
quanto la Boemia e la Sicilia di Shakespeare. E ancora Coleridge è il critico-
poeta che offre nelle sue Notes on the Tempest l’avvio più convincente per
una lettura dell’ultimo Shakespeare e perciò di The Winter’s Tale , l’idea
dell’«illusione intermedia», del dramma con trama fantastica cui si assiste né
con distacco razionale, né con perfetta illusione realistica, ma come si assiste
a un sogno in cui si vuole credere, pur consapevoli che non sia reale.
Gli ultimi drammi di Shakespeare, raccolti dagli studiosi sotto il nome di
romances, presentano alcuni temi comuni che si potrebbero riassumere nello
schema: felicità, rovina, rigenerazione. Così Pericles, del 1608 o 1609,
Cymbeline, del 1610, The Winter’s Tale e The Tempest, del 1611, e anche,
malgrado si tratti di un dramma storico, Henry VIII, del 1613. I temi trattati
sono la perdita e il ritrovamento, la riconciliazione e il perdono, la
restaurazione dell’onore e dell’innocenza calunniata: re spodestati vengono
rimessi sul trono, amicizie e alleanze interrotte vengono rinnovate e tutti i
personaggi alla fine, i cattivi ravveduti, insieme alle loro ex-vittime, si
riconoscono più maturi e più ricchi d’introspezione e autostima. Fino al nostro
secolo la critica era piuttosto divisa sulla valutazione di questi drammi. Per
molti si trattava di opere minori, lavori stanchi di un impresario-autore
vecchio che non aveva più niente da dire, una coda strascicata sul
palcoscenico dopo il tour de force delle grandi tragedie. Forse a influenzare
questo giudizio c’era ancora, consciamente o inconsciamente, la riverenza
pseudo-aristotelica per le unità di tempo e d’azione che viceversa nei
romances è messa completamente da parte. Una delle caratteristiche comuni
di queste opere è infatti il passaggio degli anni, con decadenza e crescita
prima della rigenerazione, e l’azione che attraversa mari e montagne e si
sposta da un paese all’altro.
Dal giudizio limitativo si salvava The Tempest, probabilmente perché la
rovina e l’esilio del protagonista sono narrati anziché mostrati sulla scena e
perché l’azione (rigenerazione, perdono, riconciliazione) si svolge tutta nello
stesso luogo. Non sfuggì neppure la ricchezza di valori simbolici di The
Tempest, forse fu perfino sopravvalutata. T.S. Eliot ne fece uno dei motivi
conduttori del suo Waste Land: prendendovi i simboli per la morte per acqua
e il re pescatore, e non s’accorse che, almeno per quanto riguardava i suoi