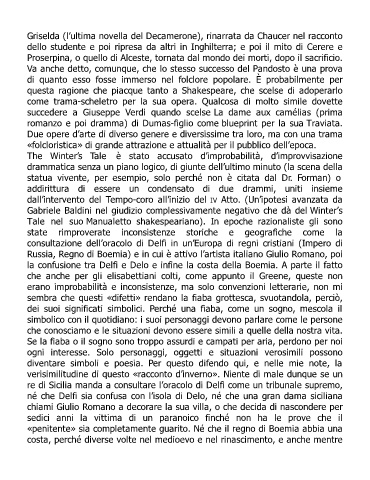Page 597 - Shakespeare - Vol. 4
P. 597
Griselda (l’ultima novella del Decamerone), rinarrata da Chaucer nel racconto
dello studente e poi ripresa da altri in Inghilterra; e poi il mito di Cerere e
Proserpina, o quello di Alceste, tornata dal mondo dei morti, dopo il sacrificio.
Va anche detto, comunque, che lo stesso successo del Pandosto è una prova
di quanto esso fosse immerso nel folclore popolare. È probabilmente per
questa ragione che piacque tanto a Shakespeare, che scelse di adoperarlo
come trama-scheletro per la sua opera. Qualcosa di molto simile dovette
succedere a Giuseppe Verdi quando scelse La dame aux camélias (prima
romanzo e poi dramma) di Dumas-figlio come blueprint per la sua Traviata.
Due opere d’arte di diverso genere e diversissime tra loro, ma con una trama
«folcloristica» di grande attrazione e attualità per il pubblico dell’epoca.
The Winter’s Tale è stato accusato d’improbabilità, d’improvvisazione
drammatica senza un piano logico, di giunte dell’ultimo minuto (la scena della
statua vivente, per esempio, solo perché non è citata dal Dr. Forman) o
addirittura di essere un condensato di due drammi, uniti insieme
dall’intervento del Tempo-coro all’inizio del IV Atto. (Un’ipotesi avanzata da
Gabriele Baldini nel giudizio complessivamente negativo che dà del Winter’s
Tale nel suo Manualetto shakespeariano). In epoche razionaliste gli sono
state rimproverate inconsistenze storiche e geografiche come la
consultazione dell’oracolo di Delfi in un’Europa di regni cristiani (Impero di
Russia, Regno di Boemia) e in cui è attivo l’artista italiano Giulio Romano, poi
la confusione tra Delfi e Delo e infine la costa della Boemia. A parte il fatto
che anche per gli elisabettiani colti, come appunto il Greene, queste non
erano improbabilità e inconsistenze, ma solo convenzioni letterarie, non mi
sembra che questi «difetti» rendano la fiaba grottesca, svuotandola, perciò,
dei suoi significati simbolici. Perché una fiaba, come un sogno, mescola il
simbolico con il quotidiano: i suoi personaggi devono parlare come le persone
che conosciamo e le situazioni devono essere simili a quelle della nostra vita.
Se la fiaba o il sogno sono troppo assurdi e campati per aria, perdono per noi
ogni interesse. Solo personaggi, oggetti e situazioni verosimili possono
diventare simboli e poesia. Per questo difendo qui, e nelle mie note, la
verisimilitudine di questo «racconto d’inverno». Niente di male dunque se un
re di Sicilia manda a consultare l’oracolo di Delfi come un tribunale supremo,
né che Delfi sia confusa con l’isola di Delo, né che una gran dama siciliana
chiami Giulio Romano a decorare la sua villa, o che decida di nascondere per
sedici anni la vittima di un paranoico finché non ha le prove che il
«penitente» sia completamente guarito. Né che il regno di Boemia abbia una
costa, perché diverse volte nel medioevo e nel rinascimento, e anche mentre