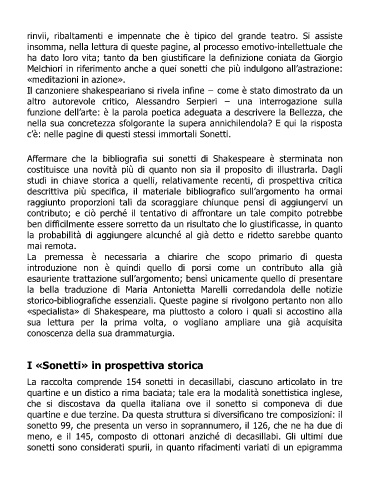Page 1764 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1764
rinvii, ribaltamenti e impennate che è tipico del grande teatro. Si assiste
insomma, nella lettura di queste pagine, al processo emotivo-intellettuale che
ha dato loro vita; tanto da ben giustificare la definizione coniata da Giorgio
Melchiori in riferimento anche a quei sonetti che più indulgono all’astrazione:
«meditazioni in azione».
Il canzoniere shakespeariano si rivela infine − come è stato dimostrato da un
altro autorevole critico, Alessandro Serpieri − una interrogazione sulla
funzione dell’arte: è la parola poetica adeguata a descrivere la Bellezza, che
nella sua concretezza sfolgorante la supera annichilendola? E qui la risposta
c’è: nelle pagine di questi stessi immortali Sonetti.
Affermare che la bibliografia sui sonetti di Shakespeare è sterminata non
costituisce una novità più di quanto non sia il proposito di illustrarla. Dagli
studi in chiave storica a quelli, relativamente recenti, di prospettiva critica
descrittiva più specifica, il materiale bibliografico sull’argomento ha ormai
raggiunto proporzioni tali da scoraggiare chiunque pensi di aggiungervi un
contributo; e ciò perché il tentativo di affrontare un tale compito potrebbe
ben difficilmente essere sorretto da un risultato che lo giustificasse, in quanto
la probabilità di aggiungere alcunché al già detto e ridetto sarebbe quanto
mai remota.
La premessa è necessaria a chiarire che scopo primario di questa
introduzione non è quindi quello di porsi come un contributo alla già
esauriente trattazione sull’argomento; bensì unicamente quello di presentare
la bella traduzione di Maria Antonietta Marelli corredandola delle notizie
storico-bibliografiche essenziali. Queste pagine si rivolgono pertanto non allo
«specialista» di Shakespeare, ma piuttosto a coloro i quali si accostino alla
sua lettura per la prima volta, o vogliano ampliare una già acquisita
conoscenza della sua drammaturgia.
I «Sonetti» in prospettiva storica
La raccolta comprende 154 sonetti in decasillabi, ciascuno articolato in tre
quartine e un distico a rima baciata; tale era la modalità sonettistica inglese,
che si discostava da quella italiana ove il sonetto si componeva di due
quartine e due terzine. Da questa struttura si diversificano tre composizioni: il
sonetto 99, che presenta un verso in soprannumero, il 126, che ne ha due di
meno, e il 145, composto di ottonari anziché di decasillabi. Gli ultimi due
sonetti sono considerati spurii, in quanto rifacimenti variati di un epigramma