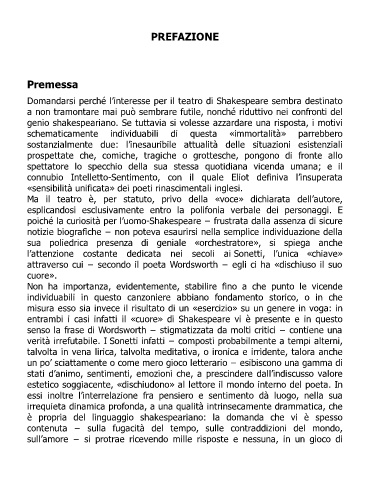Page 1763 - Shakespeare - Vol. 4
P. 1763
PREFAZIONE
Premessa
Domandarsi perché l’interesse per il teatro di Shakespeare sembra destinato
a non tramontare mai può sembrare futile, nonché riduttivo nei confronti del
genio shakespeariano. Se tuttavia si volesse azzardare una risposta, i motivi
schematicamente individuabili di questa «immortalità» parrebbero
sostanzialmente due: l’inesauribile attualità delle situazioni esistenziali
prospettate che, comiche, tragiche o grottesche, pongono di fronte allo
spettatore lo specchio della sua stessa quotidiana vicenda umana; e il
connubio Intelletto-Sentimento, con il quale Eliot definiva l’insuperata
«sensibilità unificata» dei poeti rinascimentali inglesi.
Ma il teatro è, per statuto, privo della «voce» dichiarata dell’autore,
esplicandosi esclusivamente entro la polifonia verbale dei personaggi. E
poiché la curiosità per l’uomo-Shakespeare − frustrata dalla assenza di sicure
notizie biografiche − non poteva esaurirsi nella semplice individuazione della
sua poliedrica presenza di geniale «orchestratore», si spiega anche
l’attenzione costante dedicata nei secoli ai Sonetti, l’unica «chiave»
attraverso cui − secondo il poeta Wordsworth − egli ci ha «dischiuso il suo
cuore».
Non ha importanza, evidentemente, stabilire fino a che punto le vicende
individuabili in questo canzoniere abbiano fondamento storico, o in che
misura esso sia invece il risultato di un «esercizio» su un genere in voga: in
entrambi i casi infatti il «cuore» di Shakespeare vi è presente e in questo
senso la frase di Wordsworth − stigmatizzata da molti critici − contiene una
verità irrefutabile. I Sonetti infatti − composti probabilmente a tempi alterni,
talvolta in vena lirica, talvolta meditativa, o ironica e irridente, talora anche
un po’ sciattamente o come mero gioco letterario − esibiscono una gamma di
stati d’animo, sentimenti, emozioni che, a prescindere dall’indiscusso valore
estetico soggiacente, «dischiudono» al lettore il mondo interno del poeta. In
essi inoltre l’interrelazione fra pensiero e sentimento dà luogo, nella sua
irrequieta dinamica profonda, a una qualità intrinsecamente drammatica, che
è propria del linguaggio shakespeariano: la domanda che vi è spesso
contenuta − sulla fugacità del tempo, sulle contraddizioni del mondo,
sull’amore − si protrae ricevendo mille risposte e nessuna, in un gioco di